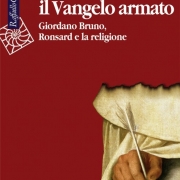L’etimologia del termine “terrore” rimanda ai verbi latini terreo, e tremo, entrambi caratterizzati dalla radice –ter, indicante l’atto del fremere per lo spavento, e sono connessi con i verbi greci tremo (“temo”, “tremo”) e treo (“fuggo tremando”, ma anche “tremo”, “temo”), riferibili al concetto di paura, non tanto psichica, quanto fisica. È dunque insita nel significato della parola l’esperienza sintomatica del corpo, collegabile sia all’atto del rabbrividire, che, soprattutto, a quello del fuggire. È inoltre da ricordare la vicinanza ontologica dei verbi greci pheugo,(“fuggo”) e il già ricordato treo, e il rapporto ancora più evidente – per rimanere in area greca – tra il verbo pheugo e il sostantivo phobos, poiché phobos ha doppia valenza, e già in Omero significa sia “spavento” che “fuga”.
Tra le tante sfumature di senso che può avere lo sgomento, è bene precisare che il terrore è quello stato d’animo che impatta immediatamente sul corpo, provocando prima il tremore e poi – conseguenza inevitabile – la fuga, che a sua volta è atto istintivo, legato alla sopravvivenza. Nei testi greci in cui si narra di guerre è facile imbattersi in treo e tresas (“fuggo tremando”), da non tradurre come “codardia”, ma da rendere come qualcosa di deontologicamente collegato a uno sconvolgimento irrazionale, una fuga contro l’ordine stabilito delle immagini belliche. Il terrore è quindi una paura totalizzante, l’estremo sbigottimento. L’irrazionalità conduce al panico, in greco panikos, dal nome del dio ctonio Pan, una delle più antiche divinità, dall’aspetto satiresco, legato alla natura e alle selve. Dal suo nome deriva anche l’espressione terror panico, in riferimento a quando il dio, se disturbato, emetteva urla abominevoli, provocando, in chi le udiva, una paura incontrollabile. Il mito più conosciuto riguardo alle grida di Pan è la Titanomachia, in particolare quando il dio spaventò Delfine, che custodiva su incarico del mostro Tifone i tendini di Zeus, proprio grazie alle sue inequiparabili corde vocali.
Altra etimologia a cui è necessario far riferimento è quella legata al termine “orrore”. La parola deriva dal latino horreo che corrisponde al greco phrisso, (“divento irto”), verbi che indicano entrambi una reazione fisica, ossia “il rizzarsi dei peli o dei capelli”, ma anche “essere rigido”, e in senso traslato “inorridire”, “rabbrividire”.
Notiamo dunque che, se il terrore è connesso etimologicamente all’azione del fuggire, l’orrore comporta un atteggiamento diametralmente opposto, causando nell’individuo quasi una agghiacciante paralisi; quest’ultima reazione è, inoltre, direttamente collegabile al concetto di “ripugnanza”.
Il discorso etimologico è assai complesso, giocato a colpi di sottili sfumature di significato, pur tuttavia utile, se non doveroso, per comprendere le altrettanto complicate emozioni umane. Parallelamente alla letteratura, anche l’arte si muove per indagare, con i propri mezzi, i sentimenti degli uomini, tentando di dare un aspetto e un volto a quello che è invisibilmente nascosto nell’animo.
Secondo il mito, l’essere ripugnante per eccellenza è Medusa, unica sorella mortale fra le Gorgoni, reclusa al di là dell’Oceano, orrenda creatura dai capelli anguiformi, la cui arma è lo sguardo che pietrifica chiunque la guardi.
Nelle più antiche rappresentazioni il mostroappare con la testa frontale e il corpo di profilo, così come nella metopa del tempio di Selinunte, Palermo, databile al 520-510 a.C. Questo è l’unico punto della decorazione del tempio che presenta una narrazione, riportando l’episodio di Perseo che, scortato da Atena, sta per sconfiggere la Gorgone. Gli scultori, probabilmente autoctoni, realizzarono le dea e l’eroe con lineamenti umani perfetti, in modo da far risaltare ulteriormente – per contrasto – quelli mostruosi del volto-maschera di Medusa, raffigurata secondo la tradizione della terracotta siracusana, con la bocca eccessivamente aperta e la lingua di fuori che tocca il mento.
Il mito ci sottolinea il collegamento tra il senso della vista e l’orrore, tra qualcosa di inguardabile e la ripugnanza che l’oggetto orripilante suscita, non solo, davanti alla figura di Medusa il corpo si immobilizza e si pietrifica, esattamente come vuole il significato etimologico di horreo.
Nella maggior parte delle rappresentazioni, la Gorgone viene dipinta non nella sua interezza, ma come testa mozzata e, così figurata, essa disgusta ancora di più, perché corpo smembrato.
Anche in Omero Medusa è citata sia come simbolo orrorifico, sia in quanto parte di un tutto ormai diviso, tanto che a comparire sull’egida di Atena è solo la testa di Medusa, circondata da Phobos, Eris, Alkè e Iokè.
Lo scudo della dea si fa metafora della guerra, il terrore e la paura si riferiscono allo Spavento e all’Inseguimento, ma il nucleo della violenza è da ricercarsi al centro della decorazione dell’arma, proprio nel volto dell’ignobile creatura, che spaventa i nemici e ricorda loro che sono brotoi, mortali.
Medusa è di certo più temibile della morte stessa, poiché la Gorgone è figurazione deturpata, relegata alla sua immagine di testa recisa, mentre Thanatos (la Morte) non deturpa le spoglie, essa è sì un fenomeno doloroso, tuttavia guardabile.
Secondo alcuni studiosi il mostro dai capelli anguiformi è metafora dell’ “inguardabilità” della propria morte, come suggeriscono altri elementi della vicenda mitologica, quali la pietrificazione, che è riconducibile alla rigidità del cadavere (il rigor mortis ) e l’elemento dello specchio, che rappresenterebbe l’identificazione del sé nella morte dell’altro.
Per contrastare la ripugnanza che Medusa suscita, non è sufficiente ucciderla, Perseo ne deve distruggere l’unicità della figura, l’individualità, quella dignità ontologica che il corpo possiede, e per questo la decapita. La testa mozzata dell’orrido essere diventa quindi simbolo dell’ampio repertorio di atrocità presenti nelle vicende umane e rappresentate nell’arte.
Con il mito di Medusa è anche chiarito un altro aspetto implicato nel concetto di “orrore”, ossia quello di “disumanizzazione”, che consiste nell’infierire su un cadavere in quanto salma vuota, perché lo si vuole nientificare. È in questo che “horreo” si distingue da “terreo”, nel gesto della figurazione.
Per i Greci l’unicità dell’individuo era contenuto nella testa, e il capo di Medusa, come vuole il gorgoneion, è sempre raffigurato frontalmente, in modo da denunciare che il raccapriccio riguarda principalmente il volto. Rimaniamo, dunque, a guardare la faccia del mostro, osserviamone l’espressione pietrificata in una spaventosa smorfia adirata; è così che compare nella maggior parte delle rappresentazioni con gli occhi bene aperti e la bocca spalancata, quasi stesse per emettere un grido nell’atto stesso in cui viene decapitata. Questi sono, infatti, gli elementi centrali del mito: l’occhio e l’urlo. Jean-Pierre Vernant sostiene che “quando fissi Medusa, è lei che fa di te quello specchio dove, trasformandoti in pietra, ella guarda la sua orribile faccia e riconosce se stessa nel doppio” (Jean-Pierre Vernant, La morte negli occhi, trad.it., il Mulino, Bologna 1987). La tematica è evidente nel mito, che sottolinea gli elementi dello specchio e del riflesso, quasi a rimarcare il mirato confronto con l’orrore, che nella narrazione si fa inevitabile e che comporta l’obbligata condivisione della ripugnanza. Tuttavia vi è anche un’altra interpretazione, tutta giocata sulla percezione di suoni che non si odono. È stata la studiosa Thalia Feldman a notare come il nome Gorgone sia riconducibile al sanscrito garg, termine utilizzato per indicare l’emissione di particolari tonalità gutturali. Thalia, attraverso questa caratteristica uditiva, vuole accomunare Medusa ad altre creature mitologiche, quali Mormo, Baubo e Gelo, tutti mostri che devono la propria identificazione a verbi afferenti alla sfera dell’udire. È necessario, a questo punto, abbracciare un discorso più ampio, che collega la voce al genere femminile nel particolare momento del legame che si instaura, per mezzo dei vocalizzi, tra la madre e il bambino. Il grido di Medusa si fa ancora più strozzato, perché lei è solo testa, staccata dal grembo, impossibilitata a generare, e così la sua espressione si tramuta in urlo offeso per quei vagiti che a lei sono preclusi.
La pari importanza dell’occhio e della bocca, risulta di facile comprensione in una delle rappresentazioni più celebri del mostro. Si tratta della tela di Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio (Milano, 29 settembre 1571 – Porto Ercole, 18 luglio 1610). Il pittore ritrae nella sua opera, intitolata Scudo con testa di Medusa ed eseguita tra il 1595 e il 1598, il capo appena reciso della Gorgone, con gli occhi sbarrati, rivolti verso l’alto, e con tanto di schizzi di sangue che arrivano a intaccare i capelli di serpente. Il punto focale dell’opera è nella bocca, all’interno della quale si intravvedono i denti bianchi, stagliati contro il nero profondo ed inquieto della gola. Davanti a questo dipinto pare quasi di sentirlo, il grido di Medusa, a tal punto da rimanere impietriti, complici del gioco perfetto della rappresentazione dell’orrore: la sensazione è muta, mentre non riusciamo a distaccare lo sguardo, attendiamo di ascoltare ciò che probabilmente non potremmo sopportare.
Esiste un’altra opera, accomunabile a questa solo per quel che riguarda la figurazione del grido che tuttavia è solo percepito e non udito: si tratta della tela intitolata Skrik, (1893–1910) eseguita da Edvard Munch, (Løten, 12 dicembre 1863 – Oslo, 23 gennaio 1944), meglio nota come L’Urlo.
Di fronte al dipinto si è testimoni di un grido cosmico, puro e totale, rappresentato da una figura asessuata, che più che umana pare un teschio deformato e consunto dall’intraducibilità del dolore. Protagonista indiscusso della composizione è il suono. L’espansione tonale è riprodotta dalle pennellate curve e di colore violento, come se Munch stesse dipingendo il propagarsi delle onde sonore.
Nient’altro accomuna i due dipinti, se non la metafisica rappresentazione dell’orrore.
Medusa è soggetto ricorrente nell’arte, tra i tanti autori che hanno deciso di raffigurarla troviamo Rubens (Siegen, 28 giugno 1577 – Anversa, 30 maggio 1640), e Bernini (Napoli, 7 dicembre 1598 – Roma, 28 novembre 1680). Il primo si confronta con la mitica creatura intorno al 1618, in una tela intitolata la Medusa, conservata presso il Museo Kunsthistorisches di Vienna. Si tratta di un’opera dallo straordinario impatto visivo, nella quale viene dipinta l’essenza stessa del macabro trionfo dell’eroe, che ha appena inferto il colpo fatale: la testa della Gorgone giace a terra con disgustoso raccapriccio, il sangue sgorga ancora copioso dalla ferita, le labbra appena socchiuse, gli occhi aperti e increduli. Il quadro è confrontabile con l’opera caravaggesca, in quanto in entrambi è raffigurato lo stesso momento cruciale e disperante, tuttavia l’opera fiamminga risulta più vivida e viscerale, forse anche per l’espressione tremendamente umana che Rubens conferisce a Medusa. È indubbio che questo sia uno dei massimi capolavori del pittore barocco, in quest’opera egli rende il macabro quasi tangibile, l’effetto è talmente ben riuscito che Charles Baudelaire (1821-1867), cultore del raccapriccio per eccellenza, decide di inserire Rubens nel suo componimento “i Fari”, contenuto nella raccolta di poesie “Les Fleur du Mal”, (1857) (Rubens fiume d’oblio, di pigrizia giardino,/guanciale di fresche carni che non l’amore/ma la vita smuove e percorre infinita/come aria nel cielo, onda sull’onda”).
Differente è l’opera di Bernini, conservata ai Musei Capitolini, a Roma. Si tratta di un busto marmoreo di 50 centimetri. La particolarità dell’elaborato è dovuta alla scelta del grande scultore di ritrarre una Medusa non ancora del tutto trasformata, come evidenziano gli accurati dettagli degli occhi aggrottati, delle labbra socchiuse e della più generale espressione di fanciulla impaurita. Si tratta di una delle pochissime opere, se non l’unica, in cui la Gorgone non è figurata come tremendo mostro orripilante, ma come una vittima indifesa dell’ira di Minerva. Bernini pietrifica nel marmo l’attimo che precede la trasformazione, denunciando al mondo l’umanità celata dietro il volto mostruoso di Medusa.
Dunque il mito impone all’orrore un volto di donna, facendo sì che i toni diventino più cupi, come se fosse necessaria la componente femminile per mostrare al mondo la vera essenza della terribilità .
Vi è nel mito, un’altra figura, anche lei situata nelle terre barbare oltre i confini della Grecia, adatta a sostenere tale affermazione.
A fare da spalla a Medusa è Medea. Le due mitiche figure hanno molto in comune, per esempio la ripugnanza che suscitano i crimini di entrambe, perché se l’orrore della Gorgone si riassume nel suo aspetto mutilato, in Medea il ribrezzo è tutto nel terribile gesto che ella compie per vendicarsi di Giasone. E poi tutte e due aprono il vulnus, la “ferita” contro l’inerme; e in entrambe le vicende è presente il tema dello smembramento: per il mostro rettileo la sfigurazione è nella decapitazione, per Medea invece, è nell’infanticidio, poiché distrugge quell’unicità che ogni madre riconosce nel figlio.

Medea è la straniera, la maga crudele, “che taglia a pezzi le vittime”, per dirla con Kerényi, ma soprattutto ella è paidoleteira (“che dà la morte ai figli”, Euripide, Medea, v. 849).
La donna è originaria della Colchide, figlia di Eeta, e secondo alcune fonti imparentata con Circe ed Ecate, dea della magia e degli incantesimi, secondo altre, invece, sarebbe figlia dell’oceanina Idia e sorella di Circe. In ogni caso il sangue stregonesco non viene messo in discussione.
Medea è figura assai complessa, così come lo è la sua vicenda. Non è solo maga conoscitrice di incantesimi, è anche colei che sfida l’ira del padre, sacrifica i fratelli, e, infine, diventa amante dell’eroe della Tessaglia, che proprio grazie a lei conquisterà il vello d’oro. Secondo quanto il mito racconta, Medea fugge in Grecia con Giasone, dove si svolgono le vicende più conosciute, al termine delle quali la donna rimane sola, esule in terra straniera, finché si unisce in matrimonio con Egeo, re di Atene, da cui ha un figlio, Medo; la tradizione vuole che Medea ordisca trame contro Teseo, erede legittimo di Egeo, per essere poi nuovamente esiliata. Alcuni vogliono che la sua vicenda termini con il ritorno in Colchide, accompagnata dal figlio, dove si riscatta per il tradimento nei confronti della famiglia, ella infatti aiuta il padre, uccidendo l’usurpatore Pelia, a sedere nuovamente sul trono.
Omero non ci parla di Medea, al contrario di Esiodo, che nella Teogonia la descrive “dagli occhi sfavillanti”, ma gli autori che meglio ne caratterizzano la figura sono Apollonio Rodio nelle Argonautiche e Euripide, nell’omonima tragedia.
È proprio quest’ultimo che la relega nella condizione di paidoleteira, scegliendo la versione secondo cui è proprio la donna a uccidere gli infanti e non agli abitanti di Corinto. Da questo momento in poi la figura di Medea è cristallizzata nel ritratto della madre infanticida e non potrà più uscire da questo contesto.
La vicenda di Medea è segnata dalla violenza, commette i suoi crimini in una sorta di climax che non può che avere finale dolente e altrettanto sanguinoso: dapprima uccide il fratello Apsirto, poi a Iolco, convince le figlie del tiranno Pelia a compiere su di lui un rituale di ringiovanimento: Medea spiega alle fanciulle che devono smembrare il padre e poi farlo bollire; una volta giunta a Corinto uccide Creusa, la promessa sposa greca del suo amato Giasone, e infine ella compie il crimine più efferato, ossia l’uccisione dei suoi stessi figli.
L’atto di Medea è reso ancora più atroce poiché è riconosciuto da lei stessa come gesto estremo, “anche se li uccidi, tu li hai amati, sventurata Medea” (Medea, vv.1249/50), le fa dire Euripide, ma nonostante il dolore, la lama non si ferma.
Nella narrazione euripidea il personaggio appare definito sotto molteplici aspetti, come sposa umiliata, poi femmina scaltra e infine donna-mostro, destinata a compiere il più orrendo dei delitti, che nessuna legge, né umana, né divina, può giustificare.
Per quanto cupa, la figura di Medea non può non ammaliare. Anche Seneca le dedicherà una tragedia, tuttavia con spirito completamente diverso, dato che la sua protagonista è creatura perfida e infernale, condannata ancor prima che l’atto scellerato venga compiuto.
Anche Grillparzer si rifà alla maga della Colchide, egli utilizza la tragedia per parlare tuttavia dell’impossibilità di intendersi tra culture diverse, partendo proprio da quel contrasto così evidente in Euripide, cioè il confronto tra la Grecia illuminata e i barbari, (oi barbaroi), che si trovano fuori dal territorio delle leggi, della giustizia e del sapere, e Medea è straniera.
Medea, come Medusa, è stata fonte d’ispirazione non solo per studiosi e scrittori, ma anche per pittori e registi.
Il pittore preraffaellita Frederick Sandys esegue la sua Medea nel 1868, chiedendo a Kaomy Grey, una donna rom che aveva conosciuto a Londra, di fargli da modella. L’autore è uno dei pochi che decide di non infierire sull’aspetto infanticida conferito alla donna, decidendo piuttosto di soffermarsi sulle sue qualità di maga. Nel dipinto, egli la raffigura nell’atto di produrre un incantesimo, mentre miscela degli strani ingredienti tipici delle ricette magiche, quali radici, rospi, gusci e conchiglie. Inoltre la luce che divampa nella composizione ne esalta l’espressione terrificante, quasi maligna, tipica delle trans in cui era solito cadere chi era esperto nell’arte dei filtri e dei sortilegi.
Delicata, nel suo rifarsi alla tradizione euripidea, è l’opera di Henri Klagmann, intitolata Medea, eseguita nel 1868, e conservata a Nancy, presso il Musée des Beaux-Arts.
In questo dipinto Medea sta per compiere il gesto estremo, ma è ancora pensosa, sola nella sua condizione di donna tradita e afflitta dal dissidio interiore che la corrode. Questo è il momento della scelta, i suoi pensieri convergono in tutta la loro drammaticità nell’espressione del volto, da cui si evince il conflitto interno tra sposa tradita e vendicativa e madre affezionata alle sue creature. Klagman vuole figurare l’estrema difficoltà in cui Medea si trova, ulteriormente sottolineata dalla presenza dei bambini, qui simili a delicati cherubini, che giocano, ignari e silenziosi, ai piedi della madre.
Anche Eugène Delacroix decide di confrontarsi con la tematica tragica, eseguendo nel 1838 La furia di Medea, esposto a Lille, presso il Palais des Beaux-Arts. Nella sua figurazione Medea è appena fuggita da Corinto con i suoi due figli, dopo aver consegnato la veste velenosa per Creusa. Le tre figure sono nascoste nelle vicinanze di una grotta ombrosa, e proprio l’ombra della caverna sottolinea l’espressione allucinata della donna, qui rappresentata con lo sguardo sconvolto ma determinato. Delacroix esegue un’opera dal gusto tipicamente romantico, inserendo nella composizione i dettagli dei capelli arruffati, sintomo di pazzia, e della nudità del petto di Medea, che in questo dipinto diventa personificazione estrema della follia amorosa. Il fatto che le figure siano prive di abbigliamento ha doppia valenza, grazie a questo escamotage l’autore simboleggia sia l’innocenza dei bambini, sia lo sconvolgimento irrazionale di Medea. L’opera è ricca di pathos, accentuato dai dettagli dell’espressione dei volti, dallo scuro della caverna che presagisce la drammaticità degli avvenimenti, dai movimenti innocenti dei bambini e soprattutto dalla posizione dei protagonisti: le tre figure sono abbracciate, ma la mano che dovrebbe proteggere gli infanti brandisce un pugnale. L’asprezza dell’opera è sottolineata anche dalla scelta cromatica, vengono prediletti toni scuri e forti contrasti, mentre la tinta cupa del panneggio risulta funzionale a dare risalto ai due lembi rossi che spuntano sotto i corpi degli infanti, simboleggianti il sangue che presto sarà versato.
La vicenda di Medea ha conosciuto davvero numerose interpretazioni, tra cui quelle cinematografiche assai particolari e intense di Pasolini e di Lars Won Triar.
La versione pasoliniana risale al 1969 e vede come interprete principale Maria Callas. La pellicola, ambientata in una sorta di altro mondo, desertico e dominato dalle cromature dell’ocra; fin dalle prime sequenze il film si dimostra metaforico e metafisico, come tutta la produzione pasoliniana. Anche in questo lavoro Pasolini decide di giocare su un dualismo, rappresentato dalla contrapposizione dei due mondi incarnati dai protagonisti: Medea, simbolo di un’arcaica barbarie, in cui vige l’irrazionalità e una interpretazione sacrale dell’esistenza, contrasta con la dimensione razionale, pragmatica ed utilitaristica personificata da Giasone.
Le prime scene sbalzano lo spettatore in una dimensione lontana e rituale, lo spaesamento di chi osserva è amplificato dal silenzio, elemento che si protrae per tutto il film. Le prime immagini mostrano il sacrificio rituale dovuto al grano, e presentano l’elemento centrale della pellicola pasoliniana, ossia il Sole, che incarna la dimensione animista in cui vive la maga della Colchide.
Altro elemento essenziale, nella Medea di Pasolini, è l’acqua. Essa è interpretata alla Bauman, come qualcosa di fluido, che ben si adatta alle situazioni, ed è anche ciò che identifica Giasone, definibile così come eroe “liquido”, che rappresenta l’uomo adulto completamente distaccato dalla natura e dal sacro.
Nonostante le enormi distanze i due protagonisti si innamorano, ed è qui che inizia la tragedia, non solo quella legata alle vicende sanguinose che tutti conosciamo, ma quella nascosta, che si svolge nella dimensione interiore dei personaggi. Medea prova a conformarsi agli usi dell’amato, tentando di sopprimere la sua barbarica irrazionalità, cosa che non solo risulta impossibile, ma emergerà poi amplificata, come preannunciato dalla sequenza dell’apparizione onirica del Sole, premonizione della irrefrenabile vendetta della donna contro Giasone.
Emblematica è la battuta che il regista fa pronunciare alla protagonista: “Niente è più possibile, ormai”, parole che sottolineano l’azione a cui Medea è predestinata, dalla quale non si può esimere e che cambierà la sua esistenza.
Come tutti i film di Pasolini, questa pellicola non ha una sola chiave di lettura, l’autore utilizza il mito per denunciare la realtà, per trattare tematiche sempre attuali e sulle quali è bene riflettere.
Consideriamo ora l’enigmatica versione di Lars Von Trier, che scelse di rappresentare come sua terza pellicola la vicenda di Medea, partendo dalla sceneggiatura di Carl Theodor Dreyer, che venne tuttavia fortemente stravolta dall’interpretazione del regista stesso.
Quella di Lars è una Medea acquosa e nordica, ambientata in lande umide e desolate, illuminate da un sole freddo e sfocato. Anche questa interpretazione è densa di metafore, a partire dalla casa della protagonista, situata in una palude nebbiosa, simbolo della mente confusa di Medea.
Così come in Pasolini era il sole l’elemento sempre presente, nella pellicola danese è l’acqua; essa bagna i desolati paesaggi onirici, e inzuppa la protagonista, che è sommersa da quell’acqua che diventa metafora del liquido amniotico presente nel grembo materno, vero e proprio passaggio metafisico tra la vita e la morte.
Il fatto che non si tratti di un’opera che passerà in sordina si evince già dalla prima scena: Medea è sulla battigia, tiene le braccia aperte come un Christus Triumphans, aspetta di essere sommersa dalla marea per poi rialzarsi con lo sguardo fisso, riprendere fiato e iniziare a narrare la sua vicenda a Egeo. La donna è dunque già colpevole, è già infanticida inscusabile, tuttavia essa prova a liberarsi del giogo che le pesa sulle spalle attraverso le parole che pronuncia. Ma anche nella versione danese, la colpa di cui si macchia Medea è atroce e imperdonabile, enfatizzata e resa ancora più drammatica dalle parole del figlio maggiore, conscio e inerme, che non può fermare la madre assassina, ma solo sussurrare: “so cosa sta per succedere”.
La pellicola di Lars Von Triar si distanzia dal mito, egli non ritiene necessaria una narrazione dei fatti, al contrario ci offre una sequenza di immagini oniriche e metaforiche che scandagliano l’animo dei personaggi, che quasi non interagiscono tra loro, ma si contorcono nel destino ineluttabile che li travolge.
In questa versione è sottolineata l’impotenza di Giasone, che compie un percorso a ritroso, dalla ricchezza fino alla miseria, causatagli dalla barbarica vendetta che Medea compie nei suoi confronti.
La protagonista che Lars raffigura è una donna potente, emblematica, che con la sua passione trasforma le sconfinate lande erbose in oceano, è lei a chiudere il film, mostrando i suoi capelli al vento, come simbolo della sua cupa e violenta supremazia nei confronti dei nemici che da sola ha annientato.
Questi dunque i volti antichi dell’orrore, Medusa e Medea, l’una ci rammenta che la distruzione dell’unicità è un crimine ontologico che supera di gran lunga la deprecabilità della morte, l’altra si fa testimone del fatto che tali crimini si accaniscono sempre sui corpi vulnerabili degli inermi.
Alessia Cagnotto