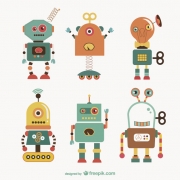Il cibo al tempo del Covid-19. La nostra vita è momentaneamente stravolta nelle abitudini, difficile per tutti ritrovarsi improvvisamente in una nuova dimensione; di colpo ci troviamo, quasi tutti, ad avere tanto tempo a disposizione come forse non ne abbiamo mai avuto. E ora che facciamo? Si rimodulano anche i rapporti con la nostra casa nella sua globalità, dagli aspetti affettivi a quelli sostanziali.
Anche il rapporto con il cibo assume sfumature ed accenti diversi. Alla notizia dell’imperativo “resta a casa” abbiamo osservato la corsa agli accaparramenti. Se leggiamo con lucidità le statistiche scopriamo che le nostre cucine sono sempre affollate di provviste, oltre il necessario, e perlopiù di cibi pronti, cibi scelti per noi da altri, gusti creati da altri che diventano i nostri, quelli che le multinazionali dei surgelati e dei cibi pronti decidono per noi. C’è quindi una presenza sempre più pervasiva della cucina collettiva (proposta dall’industria alimentare cui demandiamo la preparazione dei pasti) che include tra gli esempi sopra citati anche l’espansione del food delivery, sicuramente comodo, ma impersonale.
Tutto questo si lega drammaticamente all’espandersi dell’obesità e del cibo sprecato. I dati forniti dagli organi preposti ci dicono infatti che accumulare disordinatamente cibo crea disordine anche nel nostro corpo e nel nostro frigo: una percentuale ancora troppo elevata di cibo finisce nell’ immondizia. Per sconfiggere sia l’obesità che lo spreco occorrerebbe riappropriarsi del proprio rapporto col cibo, e quindi, quando possibile (e con la volontà e un minimo di organizzazione è possibile) diventare nuovamente padroni della gestione dei nostri pasti con un metodo semplice: preparandoli in casa. Si imparerebbe a scegliere, a comprare con più oculatezza, a riscoprire che cucinare richiede tempo, ragionamento, amore, e conseguentemente si penserebbe due volte prima di buttare.
Il primo giorno di “confino” sono entrata d’istinto in cucina e d’istinto ho preparato una focaccia salata con un impasto di farina e patata bollita. Solo quando dal forno si è sprigionato il profumo di pane fragrante che pian piano ha invaso la cucina e di seguito la casa, ho realizzato che avevo cucinato la mia madelaine di evocazione proustiana. Quella è la focaccia che faceva mia nonna quando ero piccola, che lei aveva imparato a fare in tempi duri quando la farina scarseggiava e lei integrava gli impasti con la patata. Una cosa squisita che avevo dimenticato, il mio comfort food, e da allora ne sforno una al giorno.
Questa piccola nota personale per suggerire che in questi momenti difficili in cui impera il confronto forzato con noi stessi e con i nostri famigliari, potrebbe essere, appunto, di conforto riscoprire il piacere di preparazioni semplici, magari dimenticate o sopite in un angolo della memoria, scoprire che non è poi così laborioso, accidentato e lungo dedicare un po’ più di tempo alla cucina e quindi al nostro benessere fisico e psichico.
Un ulteriore benefico effetto di questi comportamenti sarebbe la lezione che impartiremmo ai nostri figli, oggi in casa con noi, una lezione di cucina, intesa in senso culturale e sociale. Scoprirebbero cibi lontani che in futuro, come accaduto a me, potrebbero divenire la loro personale madelaine, un loro piccolo rifugio. Tutto questo mi da lo spunto per riallacciarmi ad un articolo comparso su “Il Sole 24 Ore” antecedente alle limitazioni da coronavirus, quindi in tempi di normalità, che, riferendosi al grido di dolore lanciato dai piccoli comuni in abbandono di cui è punteggiata l’Italia e condividendolo, suggeriva alle Istituzioni di concedere un aiuto economico, o ogni altra sorta di possibile e plausibile supporto, a coloro che volessero avviare una piccola attività di ristorazione in queste località per attirarvi le persone e farle tornare a vivere. Un modo per far riscoprire i piatti tipici, con i prodotti del territorio e nel contempo godere della vista di bellezze naturali e talora anche architettoniche e storiche di terre poco note o dimenticate.
Già Mario Soldati in tempi lontani, ma che in qualche modo immagino parenti di quelli che ci aspettano superata la battaglia del coronavirus, diceva che per trovare i cibi ed i prodotti genuini bisognava andare oltre i confini, intendendo come tali le grandi città. Viaggiando, andando nei piccoli paesi si potevano assaporare e scoprire i gioielli alimentari, di cui siamo effettivamente uno dei Paesi più ricchi, se non il più ricco. Cominciare a cucinare in casa i cibi della tradizione potrebbe essere un modo per ricostruire il filo della memoria e concretizzare questo sogno, contribuendo così al nostro benessere e soprattutto all’economia locale.
Sempre in tempi antecedenti le difficoltà che stiamo vivendo e che oggi occupano pressoché tutti gli organi di informazione, un autorevole quotidiano ha dedicato una pagina intera ad un Cuoco piemontese recentemente insignito di due stelle Michelin, un innovatore, uno sperimentatore, sempre alla ricerca di nuove combinazioni. Nell’intervista affermava che si sta avvalendo della consulenza di una psicologa per trasformare i suoi piatti da semplici alimenti a veicoli di emozioni e suggestioni, utilizzando, immagino, le capacità di percezione dei nostri sensi.
A mio parere un piatto può certo emozionarci con la creazione di nuovi colori, nuove consistenze, nuovi profumi, assonanze o contrasti di gusto, ed anche stupirci con effetti speciali, ma in un momento come questo credo di più nella suggestione di un ricordo, nel mettere di nuovo le mani in pasta, sentire questo tipo di consistenza famigliare e antica sotto le dita, veder lievitare e crescere un impasto così come il ricordo di esso. In un tempo come questo credo più nella valenza e nella forza della mia focaccia che in un’emozione costruita a tavolino.