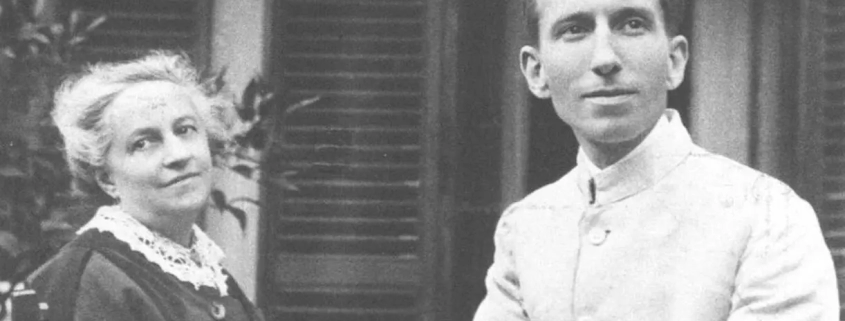Dopo l’uscita de I colloqui nel 1911, Guido Gozzano compie il viaggio in India nel ’12, lavora a Le farfalle, pubblica su «La Stampa» la più parte delle “lettere” ispirate al viaggio (1914; le ultime due vedranno la luce nel ’16 su «La Donna» e l’intero corpus sarà editato postumo nel 1917 con il titolo Verso la cuna del mondo), pubblica molte novelle su varie riviste e giornali (riunite nei volumi postumi L’altare del passato, 1918, e L’ultima traccia, 1919), la raccolta di fiabe I tre talismani (1914), e si occupa attivamente di cinema. Prima della morte prematura, il 16 agosto 1916, non dà più alle stampe libri di versi, ma non corrisponde al vero quanto talvolta ancora si afferma, che cioè non scriva più poesie: salutato positivamente dalla critica a livello nazionale (con qualche inevitabile riscontro contrario) e riconosciuto come scrittore ormai affermato, compone ancora poesie anche se questa forma letteraria non sembra più godere ai suoi occhi di un’importanza primaria. Tuttavia nell’àmbito delle poesie “sparse” – circa una settantina pubblicate in giornali e riviste o rimaste inedite – una decina circa risultano composte a partire dal 1911 e concorrono anch’esse al completamento della configurazione complessiva dell’opus poetico gozzaniano.
In questo gruppo un certo interesse offrono quelle che potremmo definire “poesie della guerra”, da relazionarsi con la situazione creatasi in Europa, poi in Italia, a partire dal fatale 28 luglio 1914 allorché l’Impero Austro-Ungarico diede inizio alle ostilità contro la Serbia. È noto che Gozzano fu profondamento deluso e amareggiato per non poter partecipare al conflitto come combattente a causa delle precarie condizioni di salute; e non perché nutrisse particolari o esasperati sentimenti nazionalistici o bellicistici, come d’Annunzio o i Futuristi, ma per sentirsi ingiustamente esentato e risparmiato da un dovere civile e patriottico comune a tutti gli Italiani. Le “poesie della guerra”, se non spuntano altri inediti, sono quattro, del tutto autonome tra loro e strutturate con schemi metrici affatto differenti, anche se vi compaiono motivi ricorrenti, come l’accorato lamento della distruzione di opere d’arte, edifici, architetture sacre (della bellezza, della cultura, quindi, ad opera della violenza) e la menzione della dantescamente proverbiale «Italia bella». Seppure dettati da sentimenti autentici e sinceri, questi testi, di ispirazione contingente e in fondo estranei alle sostanziali linee portanti dell’immaginario gozzaniano e inevitabilmente debitori (anche sotto il mero profilo letterario) a quella che era stata la Musa patriottico-civile della gloriosa Triade contemporanea (Carducci, Pascoli, d’Annunzio), non raggiungono esiti poetici memorabili (al di là di una scienza metrico-compositiva raffinatissima) e in numerosi tratti non si salvano da un’altrettanto inevitabile enfasi retorica. Sono comunque un documento importante nel quadro dell’atteggiamento tenuto da intellettuali e artisti non solo o non tanto nei confronti della guerra in sé, ma ovviamente nel senso dell’opportunità o non della partecipazione italiana. Sentita, nel migliore dei casi, come un dovere, sia pure grave e doloroso.
La messaggiera senza ulivo, 10 quartine di endecasillabi non rimati, fu pubblicata su «La Donna» del 20 settembre 2014, accompagnata dalla nota seguente: «… è giunto alle piccionaie della Società Colombofila di Milano, un colombo di Liegi, recante la targa ben nota. La bestiola, sfuggita certo a qualche piccionaia distrutta, deve aver vagato di città in città, stordita dal fragore della strage e dal rombo del cannone. Ed ha percorso non meno di duemila chilometri, prima di riparare, spennata e insanguinata, in Italia… (Settembre 1914 – I Giornali)».
Bene scegliesti l’unico rifugio / trepida messaggiera insanguinata! / (Sangue d’amico? Sangue di nemico? /
Ah! Che il sangue è tutt’uno, oltre la soglia!) // Palpiti esausta e sfuggi la carezza / e temi il rombo… È il rombo del tuo cuore. / Socchiudi gli occhi dove trema ancora / lo spaventoso tuo pellegrinare. // Ah! Sarcasmo indicibile! Tu sacra / dai tempi delle origini alla pace / la novella ci rechi – ah, senz’ulivo! – / del flagello di Dio sopra la Terra. // Ma non del Dio Signore Nostro:il dio / feticcio irsuto della belva bionda: / – Rinascono le donne ed i fanciulli, / uccideremo ciò che non rinasce! – // E le trine di marmo, le corolle / di bronzo, gli edifici unici al mondo, / i vetri istoriati, i palinsesti / alluminati, i codici ammirandi, // ciò che un popolo mite ebbe in retaggio / dalla Fede e dall’Arte in un millennio / ritorna al nulla sotto i nuovi barbari: / non più barbari, no: ladri del mondo! // Tu non tremare, messaggiera bianca; / bene scegliesti l’unico rifugio: / la spalla manca della bella Donna / eretta in pace nel suo bel giardino. // La riconosci? Dolce ti sorride / piegando il capo sotto la corona / turrita a vellicarti con la gota / e con l’ulivo ti ravvia le penne. // Ma tien la destra all’elsa e le pupille / chiaroveggenti fissano il destino; / non fu mai così forte e così bella / e palpitante dalla nuca al piede. // La riconosci? Non ti dico il nome / troppo già detto, sacro all’ora sacra! / Bene scegliesti l’unico rifugio, / trepida messaggiera insanguinata!
Al momento dell’arrivo a Milano del colombo (divenuto qui colomba «senz’ulivo», priva cioè del tradizionale simbolo della pace), la guerra («flagello di Dio sopra la Terra») non ha ancora coinvolto l’Italia (la «bella Donna / eretta in pace nel suo bel giardino»), che costituisce l’ «l’unico rifugio» in un’Europa ormai messa a ferro e fuoco. In particolare si allude alla distruzione di Lovanio, alla quasi totale devastazione del Belgio, al bombardamento della cattedrale di Reims. In tale angosciata denuncia non vi è nulla di estetizzante, ma vibra la protesta contro l’annientamento della cultura e dell’arte come espressioni più alte dell’umano destinato a soccombere nella sua inscindibile unità fisica e spirituale. L’Italia (che «non fu mai così forte e così bella / e palpitante dalla nuca al piede») tuttavia «tien la destra all’elsa e le pupille /chiaroveggenti fissano il destino»: non è quindi da escludere che anche il bel Paese, al momento fuori dal conflitto, debba operare fatali scelte armate in nome della civiltà, tanto più che i nemici sono «i nuovi barbari», l’avversario è «la belva bionda» che sacrifica a un «dio / feticcio irsuto» (non il «Dio Signore Nostro»), immagini nelle quali non sarà difficile indentificare gli Imperi Centrali, nei cui confronti (dell’Austro-Ungarico in particolare) l’Italia reclama ancora debiti territoriali e nazionali. È evidente in questo contesto l’adesione gozzaniana a una concezione patriottico-unitaria di origine risorgimentale.
La bella preda, canzone “petrarchesca” di 4 stanze di 15 versi ciascuna con libera alternanza di endecasillabi e settenari, fu pubblicata su «Lettura» dell’agosto 1915.
I. Fanciullo formidabile: soldato / dell’Alpi e tu mi chiedi / ch’io celebri il tuo gesto in versi miei! / Non trovo ritmi – oimè! – non trovo rime / così come vorrei / al tuo gesto sublime! / Ma sai tu quanto sia bello il tuo gesto, / simbolica la spoglia / dell’aquila regale che t’offerse / l’Altissimo – redento! – a guiderdone / della baldanza tua liberatrice? / La vittima che dice: / Terra d’Italia è questa! / a consenso palese / dei cieli sommi nella santa gesta? II. Tu non sapevi. Solo con te stesso / e coi fratelli in una forza sola, / sostavi sulla gola / vertiginosa, l’anima in vedetta, / protetto dalla vetta / signoreggiata. Il cuore / batteva impaziente dell’assalto. / Il cielo era di smalto / cerulo, nel silenzio intatto come / quando non era l’uomo ed il dolore… / Era il meriggio alpino, / splendeva il sole nella valle sgombra. / In larghe rote s’annunciò dall’alto / l’olocausto divino, / la messaggiera, disegnando un’ombra. III. Che pensasti nell’attimo? Colpisti. / Ben colpisti. Il vortice dell’ale / precipitò ventandoti sul viso. / E l’aquila regale / ecco immolasti sul granito alpino / come sull’ara sacra alla riscossa / del popolo latino. / E la tua mano rossa / fu del sangue ricchissimo aquilino. / Battezzasti così con la tua mano, / nella stretta che tutti ebbero a gara, / commentando l’augurio e la bravura, / battezzasti così con la tua mano / tutti i compagni tuoi, / dal giovinetto imberbe al capitano! IV. Sarcasmo inconsapevole! E tu mandi / oggi la spoglia a noi che con bell’arte / le si ridoni immagine di vita: / ma quale arte iscaltrita / può simulare l’irto palpitare / di penne e piume, il demone gagliardo / tutto rostro ed artigli e grido e sguardo / nell’ora che si scaglia? / Nessuna sorte è triste / in questi giorni rossi di battaglia: / fuorché la sorte di colui che assiste… / E – sarcasmo indicibile per noi / scelti ai congegni ed alla vettovaglia – / tu strappasti l’emblema degli eroi / ed a noi mandi un’aquila di paglia!…
L’Italia è ormai in guerra dal 24 maggio 1915. La poesia si ispira all’atto di un combattente alpino che sulle balze del Monte Altissimo (cima più elevata del Monte Baldo Trentino), come per compiere un sacrificio votivo e bene augurante, uccise un’aquila per inviarla ai compaesani perché l’imbalsamassero e custodissero fino all’auspicata vittoria. E il poeta, addirittura, non trova ritmi e rime (palese richiamo nobilitante a Rime e ritmi, ultima recente raccolta poetica carducciana del 1899) adeguati per celebrare il gesto del «fanciullo formidabile». In calce a un’esposizione innegabilmente nutrita di retorica, si potrà però apprezzare l’autobiografica dolorosa asserzione che «nessuna sorte è triste / in questi giorni rossi di battaglia: / fuorché la sorte di colui che assiste…» e che, come il poeta celebrante, non può partecipare attivamente – s’intende – «alla riscossa / del popolo latino».
La basilica notturna, pubblicata su «La Donna» del 20 dicembre 1915. Sorta di elegia in 3 strofe di distici di versi martelliani o alessandrini. La prima strofa comprende 6 distici, la seconda 9, la terza 4. In ogni distico il settenario che apre il primo verso rima con il secondo settenario del secondo verso, il settenario che chiude il primo verso rima con il primo del secondo verso, secondo lo schema ab/ba. Fanno eccezione il primo distico della prima strofa, dove le rime sono ab/ab, e il quarto distico della terza strofa (conclusivo) anch’esso con rime ab/ab. (Lo schema metrico di questa poesia è lo stesso di Le due strade e Il responso in La via del rifugio).
Pax tibi Marce, Evangelista Meus. I. D’oro si fanno brune le cupole stupende, / ma sotto il cielo illune il cielo d’oro splende. // Splende l’emblema come nel codice ammirando: / Venezia trepidando nel sacrosanto nome. // Sta l’Angelo di Dio, sta col fatale incarco / lassù «Pace a Te, Marco, Evangelista mio!» // Intorno gli fan coro tutti i Profeti, in rari / musaici millenari. Palpita il cielo d’oro. // Il palpito millenne corre Santi e Madonne; / vivono le colonne, le fragili transenne. // Ma quale antica ambascia il Tempio oggi ricorda, / difeso nella sorda materia che lo fascia? // II. Pei ciechi balaustri, per le navate ingombre / passano grigie l’ombre di tutti i dogi illustri. // Dice uno Zani: Vissi pel tempio apparituro. / Quale nemico oscuro sale dai ciechi abissi? // Dov’è l’Icona fine di quattromila perle, / mirabili a vederle tra l’opre bizantine? / Dove le Croci greche, sante in Gerusalemme, / i codici, le gemme, i calici, le teche? // E dice un Selvo: Tolsi i marmi d’oltremare: / posi con questi polsi la pietra dell’altare. // La Bibbia m’ammoniva. Sculpii divotamente. / La pietra fu vivente: dov’è la pietra viva? // Gli Zorzi i Mocenigo i Vanni i Contarini / i Gritti i Morosini i Celsi i Gradenigo // guatano il legno greggio che cela marmi ed ori / – Minacciano i tesori i barbari e il saccheggio? // Risorgono al reame i Turchi gli Unni i Galli? // Tornarono i cavalli all’ippodromo infame? // III. Sta l’Angelo di Dio, sta col fatale incarco / lassù «Pace a Te, Marco, Evangelista mio!» // Santo dei santi eroi guerrieri e marinai, / o Santo, o tu che fai che «noi si dica noi» // quale remota ambascia il Tempio tuo ricorda, / difeso nella sorda materia che lo fascia? // Minacciano i tuoi beni, la Chiesa disadorna / Barbari e Saraceni! Ah! Ciò che fu ritorna! – Venezia, 1915.
Forse il più interessante tra i componimenti “di guerra” gozzaniani. Per la sua posizione, Venezia fu particolarmente esposta agli attacchi aerei austro-ungarici che le causarono non pochi danni. Lo spunto dell’elegia è allora offerto dalla necessità che si impose di mettere in salvo in luoghi sicuri i tesori d’arte contenuti nella Basilica di San Marco a sua volta protetta con sacchi di sabbia e debitamente oscurata e tenuta in ombra. Degna di nota l’enumerazione di oggetti, gioielli, opere d’arte, anche affidata alle «ombre di tutti i dogi illustri», secondo una gozzaniana tecnica elencatoria di nominazione di realtà concrete (persone comprese) variamente attuata, ad esempio, in poesie di taglio para-realistico e andamento “narrativo” come L’amica di nonna Speranza, La signorina Felicita, Torino, In casa del sopravvissuto, Il castello d’Agliè (e in parte nella precedente La messaggiera senza ulivo).In questa poesia, non a caso, tra chi minaccia i tesori e il saccheggio ci sono «i Turchi gli Unni» (i Galli c’entrano poco, se non per analogia e per rimare con «cavalli»…), «Barbari e Saraceni», in palese riferimento all’Impero Ottomano (e a tutto quanto storicamente significò per la città lagunare) alleato degli Imperi Centrali nella guerra in corso. In ultima analisi, un ulteriore e preoccupato elogio dell’arte, della bellezza, della gloria trascorsa, valori universali tragicamente minacciati dal rinascere di una temperie sanguinosa di inaudita disumanità.
Ai soldati alladiesi combattenti, sonetto, fu incluso in un piccolo calendario stampato ad Agliè nel gennaio del 1916 «a beneficio dei combattenti» (Calcaterra).
O tu, che d’odio sacrosanto avvampi / i confini del Barbaro cancella! / Con l’anno sorga una migliore stella / a consolar gli insanguinati campi! // Tu che combatti per l’Italia bella, / tra cupi rombi e balenar di lampi, / salve! Ed il cielo provvido ti scampi / alla sposa, alla madre, alla sorella! // Il tuo paese attende il tuo ritorno. / Tempi migliori ti saran concessi, / se in dolce pace finirà la guerra. // I nostri voti affrettano quel giorno; / tra belle vigne e biondeggiar di messi, / ritornerete, figli della terra!
I genitori di Gozzano erano entrambi originari di Agliè e nella località canavesana non lontana da Torino possedeva la bella villa “Il Meleto” l’avvocato Massimo Mautino, facoltoso proprietario terriero e deputato, nonno materno del poeta che amava trascorrervi i mesi estivi. Il sonetto è un gentile omaggio ai “concittadini” impegnati nel conflitto, augurando loro un felice e vittorioso ritorno per riunirsi agli amati famigliari e poter nuovamente dedicarsi alle attività agricole tipiche del territorio. Pur ribadendo il dovere di combattere «il Barbaro», l’estrema parola di Guido, che morirà di lì a sette mesi, è di instancabile condanna della guerra e di ardente umanissimo desiderio della «dolce pace»[1].
[1] I testi citati sono tratti da Guido Gozzano, Opere, a cura di Giusi Baldissone, UTET Libreria, Torino 2006.