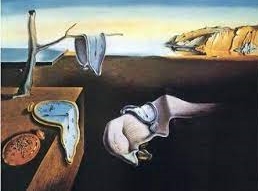Un breve scambio di email sull’interpretazione del fascismo come fenomeno totalitario, avuto con due amici e colleghi che onorano la categoria degli storici contemporaneisti italiani, Roberto Pertici e Giovanni Sabbatucci, mi ha riconfermato in una mia vecchia idea. Per dirla in rapidissima sintesi: l’uso ideologico delle categorie politiche e storiografiche è sempre un’arma a doppio taglio da maneggiare con estrema prudenza. Nella fattispecie, dire che il fascismo fu totalitario può servire alla sinistra per mettere fuori gioco, senza remissione, quanti a quell’esperienza debbono il loro apprendistato politico e culturale: con chi ha fatto parte dell’universo nazifascista, infatti, non si può avere alcun rapporto; ma, nello stesso tempo, la denuncia del carattere totalitario del governo mussoliniano rischia di esporre la sinistra dura e pura al ridicolo giacché se davvero il fascismo fu una dittatura terroristica—e solo una vittima delle metastasi ideologiche può pensare a un totalitarismo senza terrore: sarebbe come parlare di un liberalismo senza habeas corpus, senza limitazione del potere statuale e senza divisione dei poteri—,ogni assimilazione di Berlusconi al duce diventa assurda, un boomerang sicuro, come mostrano, involontariamente, gli elzeviri dei giuristi, degli storici, dei filosofi che sulla ‘Repubblica’ denunciano la svolta autoritaria segnata dal governo di centro-destra. D’altra parte, accreditare l’immagine (quella più vicina alla verità storica) del fascismo come ‘totalitarismo imperfetto’, caratterizzato da una strategia ben calibrata di repressione e di (relativa) libertà, ovvero da zone nere disposte a macchia di leopardo, se, da un lato, potrebbe più facilmente consentire il confronto del regime con i governi di centro-destra, dall’altro, potrebbe comportare il rischio—non sottovalutabile– di indebolire, con il ridimensionamento del carattere demoniaco del PNF, la mistica antifascista: il legame duce/cavaliere sul piano di una seria analisi storico-politica, resterebbe, beninteso, assolutamente privo di fondamento ma con qualche apparenza in più di credibilità. Specialmente se si considerano:
a)il peso culturale della immarcescibile vulgata antifascista che, per citare un articolo idealtipico di Mario Pirani, A chi serve la versione edulcorata del fascismo (‘La Repubblica’ 23 aprile 2008), riduce il fascismo ad “una dittatura in primo luogo antiliberale, che soffocò la libertà di stampa, di parola, di associazione, di sciopero; soppresse la libertà rappresentativa; istituì tribunali speciali, incarcerò e talora assassinò gli oppositori; infine trascinò l’Italia in una guerra rovinosa contro le più grandi potenze del mondo”, come se non ci fosse null’altro da dire e come se la scienza politica, che da più di mezzo secolo ha studiato a fondo il fenomeno, fosse rimasta ferma a Piero Gobetti;
b) l’attribuzione al centro-destra di taluni di quei caratteri (il monopolio televisivo, le leggi antisindacali, l’appiattimento sulla politica imperialista americana, il tentato asservimento della magistratura etc.)
Al di là dei rispettivi inconvenienti, però, le due diverse interpretazioni — la ‘totalitaria’ e la ‘semitotalitaria’ – sono frecce che la sinistra del ‘muro contro muro’ custodisce gelosamente nella sua faretra. Anche se, va detto, da qualche tempo sembra privilegiare l’interpretazione ‘forte’, quella sostenuta da uno storico, Emilio Gentile, che, per molti anni fu accanto a Renzo de Felice per distaccarsene in seguito proprio sulla vexata quaestio della natura del regime fascista. Nel lungo brano riportato qualche settimana fa dal domenicale del ‘Sole 24 Ore’, in occasione della riedizione de La via italiana al totalitarismo (Ed. Carocci), Gentile, in polemica con Hannah Arendt, ribadisce per l’ennesima volta che il carattere totalitario del regime fascista sarebbe stato dimostrato da tempo dai” risultati della ricerca storica”. Alla Arendt, che com’è noto, ne dubitava, vengono contrapposti” studiosi come Luigi Sturzo, Hans Kohn, Michael Florinsky, Raymond Aron” e altri che “malgrado le loro differenti e opposte ideologie, nella loro analisi del totalitarismo, avevano considerato il fascismo un regime totalitario”. In realtà, Gentile mostra sia di non aver letto l’analisi forse più acuta e profonda che sia stata scritta, almeno nel nostro paese, sul Totalitarismo, la voce curata da Mario Stoppino per il Dizionario di Politica di Norberto Bobbio e Nicola Matteucci, sia di aver dato poco peso agli studi, ormai classici, di Domenico Fisichella; ma, quel ch’è peggio, attribuisce agli autori che cita tesi opposte a quelle da essi effettivamente sostenute, come nel caso di Raymond Aron. Stoppino, che sulla nazista ‘etica del destino’ aveva svolto riflessioni tanto originali quanto penetranti, aveva visto nel terrore totalitario uno degli elementi cruciali—accanto all’ideologia, al partito unico e al dittatore carismatico—del fenomeno totalitario. “Il terrore totalitario—aveva scritto– che è sprigionato congiuntamente dal movimento di trasformazione radicale imposto dalla ideologia e dalla logica della personalizzazione del potere, inibisce ogni opposizione e anche le critiche più tenui e genera coercitivamente l’adesione e il sostegno attivo delle masse al regime e al capo personale”. La sua non era una mera analisi di ‘storia delle idee’ ma nasceva sul solido terreno di una scienza politica realistica e weberiana, in cui le istituzioni e le loro dinamiche (la politica come ‘struttura’ e la politica come ‘processo’) assumevano un ruolo decisivo nella spiegazione dei fatti storici. Quanto ad Aron, Gentile forse ignora che nel saggio Existe-t-il un mystère nazi?—v. ‘Commentaire’, vol.2, n.7, 1979– il Tocqueville del XX secolo scriveva testualmente:
<Il regime di Mussolini non fu mai totalitario: le università, gli intellettuali non furono mai irreggimentati anche se la loro libertà d’espressione fu ristretta. Mussolini prese a prestito l’antisemitismo dalla Germania nazista ma non soppresse né la monarchia né le istituzioni tradizionali dell’Italia> .Il duce fu <più simile a un caudillo dell’America latina che a un Hitler>.
Sennonché la migliore confutazione del discutibile impianto teorico di Gentile viene da un personaggio insospettato, da un giurista che sarebbe stato considerato, in seguito, la più alta coscienza morale dell’antifascismo e che, nell’ottavo anniversario del sacrificio di Duccio Galimberti, avrebbe dettato la nota epigrafe <Lo avrai camerata Kesselring il monumento che pretendi da noi italiani..>, Piero Calamandrei. Nella Conferenza tenuta a Firenze il 21 gennaio 1940, a due anni dalle leggi razziali, parlando ai giovani della fede nel diritto (il saggio è stato ripubblicato da Laterza), Calamandrei attaccava a fondo i regimi comunista e nazista che pretendevano, entrambi, dai magi-strati <di cessare di essere i servitori delle leggi vigenti per diventare invece i promotori delle leggi dell’avvenire>. <Là dove impera il principio della legalità, faceva osservare, il giudice non deve conoscere altro diritto che quello consacrato nella legge>. E’ quanto, a suo avviso, si verificava in Italia dove <nel campo dei congressi giuridici e delle riforme legislative gli interpreti ufficiali del pensiero italiano sono sempre rimasti fedeli al sistema della legalità, com’è avvenuto in recenti congressi internazionali di diritto penale comparato nei quali i delegati dell’Italia si sono decisamente schierati a difesa del principio nulla poena sine lege o come è avvenuto ancor più recentemente nei lavori del Comitato italo germanico, durante i quali i delegati italiani (Carlo Costamagna e Leopoldo Piccardi) hanno svolto <una lucida relazione su Il giudice e la legge>. E, a riprova della differenza incolmabile che separava l’Italia fascista, dalla Germania hitleriana e dalla Russia di Stalin, il giurista fiorentino citava le <autorevoli e definitive affermazioni contenute nel discorso tenuto il 16 ottobre 1939 dal guardasigilli Dino Grandi, nel quale |…| energicamente si proclamava che ‘le frontiere del diritto, del nostro diritto romano e italiano, debbono essere difese da noi colla stessa tenacia con cui difendiamo le nostre frontiere storiche e geografiche>. Sconcerta questo quadro positivo della pratica del diritto nel regime fascista, non certo dettato da mero opportunismo ma, semmai, dal generoso disegno di mettere in guardia il paese, usando la leva patriottica della civiltà giuridica italiana, da alleanze impure con i regimi totalitari. In ogni caso, una conferenza come quella di Calamandrei sarebbe stata concepibile a Mosca o a Berlino? Ed è irrilevante, come ricorda spesso Sabbatucci, che il duce sia stato arrestato, su ordine del re, da un reparto di carabinieri ovvero da militari che, evidentemente, consideravano il giuramento di fedeltà al monarca ben più impegnativo di quello prestato al capo del governo? <Nell’Italia fascista—per citare ancora Stoppino—la mobilitazione della società non fu mai paragonabile a quella conseguita dal regime hitleriano e da quello staliniano; né furono mai presenti, nella loro dimensione specifica gli elementi costitutivi del totalitarismo. |…| Il partito fascista fu un’organizzazione piuttosto debole, di fronte al quale la burocrazia dello Stato, la magistratura e l’esercito conservarono gran parte della loro autonomia; e la cui azione di indottrinamento ideologico fu limita e venne a patto per esempio con le potenti organizzazioni cattoliche. Il terrore totalitario mancò pressoché del tutto>. Si tratta di un’analisi, per certi aspetti, definitiva che conferma, a un livello rigorosamente politologico, le ricerche di Renzo De Felice (che aveva un’altissima considerazione per Stoppino al punto da adottare, nel suo corso alla Facoltà di Scienze politiche della Sapienza un testo dello studioso pavese che gli studenti trovarono particolarmente ostico) ma che, temo, non metterà fine agli usi ideologici delle categorie storiografiche. In realtà, il problema ancora in sospeso è tanto semplice quanto cruciale e consiste nello stabilire se il fascismo debba trovare una spiegazione nel<sistema sociale>—si tratti di malattia morale, di autobiografia della nazione nei suoi aspetti peggiori, di reazione egoistica di una borghesia minacciata nei suoi privilegi—o nel <sistema politico>. In altre parole, indipendentemente dagli interessi particolari di classi e di ceti determinati, ci fu o non ci fu una crisi oggettiva della ‘comunità politica’– seguita alla guerra mondiale e ai traumi profondi che ne derivarono—alla quale i ‘ceti medi emergenti’, sicuri dell’acquiescenza del paese, cercarono di porre rimedio anche contro le istituzioni (relativamente) liberali e democratiche ereditate da Cavour e da Giolitti? <Se il 14 luglio è la festa di tutti i francesi, degli eredi dei giacobini come dei vandeani, dei laici come dei cattolici, di chi si richiama alla Comune e dei gollisti che inalberano Giovanna d’Arco perché tutti gli italiani non debbono finalmente ritrovarsi nel 25 aprile e nel 2 giugno?>. Alla domanda che si pone Pirani non è difficile rispondere. Non ci può essere conciliazione se si continua a vedere nel fascismo una forma del Male e si pretende l’atto di contrizione da quanti, a torto o a ragione, guardano ad esso, o meglio a taluni suoi aspetti, con qualche nostalgia—quasi tutti, va detto, ne espungono l’appendice razzista e l’Asse Roma-Berlino. Alle celebrazioni nazionali debbono partecipare tutti con l’abito della festa: è inconcepibile che alcuni siano ammessi solo col cilicio addosso e il capo cosparso di cenere. Occorre riconoscere che se gli amanti della libertà e della democrazia coltivavano stili di vita del tutto incompatibili con quelli proclamati dal regime e dal movimento fascista, altri italiani potevano nutrire idealità diverse, ad esempio una fedeltà alla Nazione spinta fino a tenere in nessun conto le <dee dell’89>. Non fu, ripeto, un mero scontro tra il Bene e il Male ma tra valori inconciliabili se spinti all’estremo, che giustificavano opposte soluzioni alla malattia mortale che minacciava uno Stato nazionale esaurito e privo di forte legittimità. E’ superfluo dire da quale parte stavano i liberali, ma forse è venuto il momento di riconoscere, una buona volta, che anche i loro nemici avevano un’etica politica, una disposizione al sacrificio, un progetto di riscatto del paese prostrato dalla guerra. Finché durerà la sua criminalizzazione, il fascismo rimarrà sempre una facile risorsa retorica, diversamente utilizzata a seconda dell’interpretazione che se ne sceglierà (totalitarismo perfetto o imperfetto). Quando la storia del ventennio sarà riconsegnata all’Italia, c’è da credere, ci sarà tanta poca voglia di farne un criterio di divisione tra i partiti quanta ce n’è oggi nel dividersi politicamente nel nome di Cavour o nel nome di Garibaldi.
II
Il dovere della memoria nel nostro paese―ma forse anche nel mondo―sta diventando il diritto ad abbandonare il laboratorio degli storici per partecipare attivamente ai riti collettivi del ricordo, della esecrazione, dei moniti solenni. E poiché la memoria è soprattutto quella della Shoah (ed è comprensibile giacché il razzismo nazionalsocialista è stato l’episodio più sconvolgente del XX secolo), tutto ciò che è collegato con l’antisemitismo ne viene contaminato. In altre nazioni, penso soprattutto alla Francia, il fondamentalismo ideologico trova sempre degli anticorpi—si veda il Dictionnaire historique et critique du racisme, a cura di Pierre-André Taguieff (Puf 2013), un intellettuale della stoffa dei Raymond Aron, dei Jean-François Revel, dei François Furet—; da noi li si cerca invano. In Italia, più che altrove, il riflesso condizionato del pensiero è diventato lo slippery slope argument (la teoria del piano inclinato) per cui basta differenziarsi un poco dal pensiero dominante e dalla pedagogia buonista che lo sorregge per ritrovarsi sull’orlo di un pendio che porta alla perdizione morale e all’imbarbarimento della società. Il risultato è il trionfo dell’ipocrisia: il discorso pubblico è una cosa, quello privato un altro. Ma non è soltanto questione di discorso e di opinioni ma anche di vissuto e di esperienze collettive: se qualcuno dice che durante il ventennio i treni arrivano in orario o che alcune opere e istituti del regime (come l’IRI) all’estero riscossero molta attenzione, corre il rischio di essere isolato da un cordone sanitario. Del ‘male assoluto’ può esserci memoria ma non storia.
Nel 1975, quando uscì la celeberrima Intervista sul fascismo di Renzo De Felice a Michael Ledeen sembrava quasi che ci si stesse avviando verso una comprensione più distaccata del nostro passato. Il docente reatino venne aspramente attaccato—soprattutto dalla cultura azionista che parlò di ‘pugnalata dello storico’—ma altresì difeso anche da comunisti doc come Giorgio Amendola, la cui Intervista sull’antifascismo (1976), a cura di Piero Melograni, confermava non poche tesi dell’altra. A torto si ritenne allora di poter mettere finalmente una pietra sul passato e, sull’esempio della Spagna, di essere pronti anche noi a sottoscrivere il civilissimo ‘patto dell’oblio’ con cui post-franchisti e antifranchisti avrebbero segnato l’ingresso del loro paese nell’era democratica. In realtà, avevamo sottovalutato sia l’Italia sia la Spagna, da anni ormai in preda all’iconoclastia antifascista e decisa a far rivivere― “nella memoria” ― ovviamente la guerra civil, come mostra la vicenda della Val de los Caidos.
Il fatto è che in una repubblica, come la nostra, povera di idee e a corto di progetti di medio e lungo termine, alle prese con una società civile sempre più in affanno, con un debito pubblico salito alle stelle e con una decadenza economica pare inarrestabile, il collante antifascista, almeno per una parte dei vecchi partiti, è rimasto il solo produttore di identità etico-sociale nella desertificazione dei valori. E poiché il fascismo è finito da più di settant’anni se ne scovano i presunti eredi per ravvivare l’antica fede anpista. All’armi, all’armi siam tutti antifascisti! Ormai è una gara a chi le spara più grosse giacché le sole ‘memorie’ non bastano più―anche se “la scuola ha fatto un ottimo lavoro”, come riconosce Simon Levis Sullam intervistato da Lucia Campagnino sul ‘Secolo XIX’ del 27 gennaio (Nessuno è immune dal rischio del virus dell’odio e del razzismo). Sullam lamenta che più “non si parla della dittatura fascista e della sua natura criminale, che si rivelò ben prima delle leggi razziali del 1938, fin dalla Marcia su Roma del 1922” e annuncia che “è arrivato il momento per gli italiani di sviluppare le implicazioni del loro impegno antirazzista”. Parole di colore oscuro, dal momento che fioccano le leggi che puniscono il reato d’incitamento all’odio razziale e, in genere, di ‘apologia del fascismo’. Che fare allora? Non sono sufficienti le scuole, le questure e i tribunali? dobbiamo scendere sulle strade e sulle piazze per gridare il nostro no pasaran? Se fin dalla marcia su Roma il fascismo mostrò la sua ‘natura criminale’, dobbiamo cancellare strade, scuole, piazze intitolate a grandi liberali come Benedetto Croce o Luigi Einaudi che di quella natura non si avvidero almeno fino al delitto Matteotti? Alberto Asor Rosa, nel 1975, aveva definito il fascismo “la fogna” in cui era confluito l’aspetto arcaico, arretrato, provinciale e schizofrenico della cultura italiana postunitaria”. Recentemente ha parlato di “regime criminale di massa” parafrasando la nota espressione “regime reazionario di massa” impiegata da Palmiro Togliatti nelle sue lezioni sul fascismo (lezioni, sia detto per inciso, di grande interesse sul piano storico-teorico pur se ideologicamente viziate): il ‘reazionario’, ormai, è diventato sinonimo di ‘criminale’, in uno stile di pensiero che sarebbe piaciuto al benemerito Comitato di Salute Pubblica del 1793.
Sulla stessa linea inquisitoria, Furio Colombo, su Radio3, ha sostenuto essere blasfemo equiparare fascismo e comunismo, giacché il primo era fin nel profondo antisemita e razzista (per loro fortuna, Stalin morì prima che potesse attuare il suo piano di sterminio degli ebrei russi, al quale aveva destinato due Lager ai confini dell’URSS). Si ha quasi la sensazione che si stiano spezzando tutti i freni inibitori, che una volta garantivano buon senso e buon gusto, e che la storia reale di quel che avvenne tra il 1922 e il 1945 non interessi, alla fin fine, più nessuno. Dalle vette del sapere—v. l’Umberto Eco teorico dell’Ur-Faschismus—agli scantinati della mezza cultura—v. il libello di Michela Murgia, Istruzioni per diventare fascisti (Einaudi 2019)—è tutta una corsa al rialzo tra chi lancia più anatemi, infiamma di più gli animi, acquista un maggior numero di benemerenze denunciando i delitti ‘contro l’umanità’ .
In questo clima (artificialmente) incandescente, non è l’erogazione della violenza in quanto tale a suscitare orrore e disperazione ma solo la violenza di una cultura politica determinata, quella che non si riconosce nella filosofia delle ‘magnifiche sorti e progressive’ e parla di decadenza dell’Occidente. Nell’articolo pubblicato l’anno scorso sulla ‘Verità’ (5 febbraio) Dittatura della memoria ultimo atto, Marcello Veneziani scriveva con amara ironia: “Il comunismo non è mai esistito, se non come idea benefica e generosa, deturpata da alcuni incauti dittatori, di cui si perdono le generalità nella preistoria. Ma sopravvive intatta la sua Utopia nell’alto dei cieli e guida il mondo all’uguaglianza e i migranti alla conquista dell’Occidente. Non c’è alcun ricordo pubblico di quei regimi, di quei massacri, di quegli eventi; e non c’è alcuna responsabilità storico in chi abbracciò il comunismo, sostenne i regimi più criminale, lavorò per il suo avvento in Italia. Il comunismo? Ma di che parli? E’ solo un’ossessione paranoica nelle vostre teste”. Veneziani è un intellettuale militante di destra—anzi può considerarsi lo studioso più informato e profondo della sua area ideologica: non a caso è stato vicino a quello che può ritenersi il più grande filosofo politico italiano della seconda metà del Novecento, Augusto Del Noce; è portatore di una filosofia politica che non è la mia e, come i suoi antagonisti di sinistra, non è mai entrato nell’universo liberale, nel quale ho fissato stabile dimora. Ma proprio per questo mi dispiace di dovergli dare ragione. Oggi chi ricorda più—se non in qualche documentario televisivo che certo non entra nelle scuole—i milioni di morti ammazzati da Stalin? la ferocia con cui Mao si sbarazzò dei suoi avversari politici, a cominciare da Liu Shaoqi e sacrificò al folle progetto del grande balzo in avanti, il triplo degli ospiti dei Lager nazisti? Le piramidi di teschi di Pol Pot—un dittatore paranoico più spietato di Hitler e degli altri due messi assieme?
Lo stucchevole universalismo che ispira la nuova isteria antifascista insegna nelle scuole che solo ad Auschwitz e a Birkenau si capisce cos’è stato il nazismo ma si rifiuta di accettare il principio inverso che solo nei Gulag si comprende cos’è stato il comunismo. E avrebbe ragione a non ridurre quest’ultimo—portatore di un valore antico che risale a Platone—allo stalinismo ma, per essere coerente, dovrebbe applicare le stesse misure all’odiato nemico ideologico, riconoscendo ad es. che i pregiudizi antisemiti, pur presenti nel fascismo italiano come in vasti settori sociali condizionati dal tradizionalismo cattolico, non avevano come sbocco fatale le infami leggi razziali del 1938—peraltro indigeste a non pochi fascisti a cominciare da Italo Balbo e decisamente estranee al comune sentire della borghesia italiana (alla quale il duce voleva dare un pugno nello stomaco con l’antisemitismo di Stato).
Nell’artificiale rigurgito antifascista ‘fuori stagione’ c’è un elemento paradossale. A ben riflettere, infatti, i Simon Levis Sullam, gli Asor Rosa, i Furio Colombo, le Michela Murgia, gli Umberto Eco sono il ‘paese legale’ dei nostri giorni, quello che dà le direttive ideali e vuole imporre alla gente comune simboli remoti poco sentiti. Il ‘paese reale’ sarà pure qualunquista ma certo non li sta a sentire e anzi è spinto a votare per i veri populisti/nazionalisti/sovranisti proprio per reagire al Minculpop antifascista mai stanco di demonizzarli col ricordo dei loro ‘criminali’ antenati. “Ogni giorno, ha scritto Veneziani, i telegiornali ricordano Auschwitz e dintorni, c’è sempre un motivo, un pretesto, un personaggio, una data da ricordare. La tardiva scoperta di un sopravvissuto finora ignoto, la confessione dopo ottant’anni di silenzio che a casa sua nascondevano gli ebrei. La Giornata della Memoria è ogni giorno, è un’istituzione permanente, una preghiera quotidiana. Una rubrica fissa a cui dedicare uno spazio sacro e intangibile”. Dobbiamo lasciare alla destra la lucidità dello sguardo?