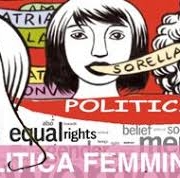Per età giolittiana si usa intendere il periodo dall’inizio del Novecento alla vigilia della Grande Guerra. Ma quella periodizzazione è riduttiva, perché per un verso sminuisce l’opera di Giolitti nell’Italia umbertina, e per altro verso non rende il merito dovuto all’ultimo Giolitti che nel 1919 pervenne con il discorso di Dronero alla più compiuta espressione della sua visione politica. La vastissima letteratura sul giolittismo è tuttora sottoposta a revisioni di segno diverso e contiene soprattutto per il passato interpretazioni severamente critiche anche sul versante liberale. Ne ho tratto alcune conclusioni nel 1999 nello scritto Interpretazioni del liberalismo giolittiano, pubblicato nel volume La svolta di Giolitti (Ediz. Bastogi). Ci ritorno adesso per chiedermi cosa rimanga del liberalismo giolittiano, e resto fermo alla convinzione espressa allora: nell’arco lungo che intercorre da Depretis a Mussolini, il giolittismo fu per la storia d’Italia la sperimentazione più consistente della democrazia liberale; ossia di una democrazia che aveva la sua arena nel parlamento, e di un liberalismo che aveva per programma strategico l’accesso nell’arena politica dei ceti più vasti, che erano stati lasciati a margine dal liberalismo tricolore della Destra Storica. Della Destra Storica Giolitti riconosceva i meriti patriottici, incluso il risanamento del bilancio dello Stato; e vi ravvisava le glorie più alte del vecchio Piemonte, ritrovandosi per intero nella fedeltà al partito di Cavour, D’Azeglio, Rattazzi, Lanza, Sella. Fu nel nome di quella fedeltà che nel 1924 Giolitti contrappose la lista liberale al listone governativo, seppure con i distinguo che vedremo; e l’anno seguente lasciò la presidenza dell’amministrazione provinciale di Cuneo per non rinnegare quella continuità che durava dal 1848. Ma non sfuggiva a Giolitti l’arretratezza in cui il governo patriottico della Destra aveva di necessità lasciato vaste aree del paese; e quei ceti popolari che avevano subìto le spietate “imposte sulla miseria”, e VALERIO ZANONE CIÒ CHE È VIVO DEL LIBERALISMO GIOLITTIANO 18 dovevano essere avviati alla partecipazione della vita pubblica, se si voleva allargare il fondamento delle istituzioni democratiche. La visione di Giolitti fu, in relazione al suo tempo, il caso più coraggioso di riformismo liberaldemocratico conosciuto nella storia unitaria d’Italia. Non sorprende quindi che i suoi avversari più implacabili fossero i reazionari ostili al parlamentarismo, e i letterati dell’irrazionalismo retorico, in una parola gli ambienti in cui fermentavano già i germi che avrebbero portato al fascismo. Ma critica del giolittismo fu anche in buona parte la cultura liberale del tempo, e il fatto merita qualche notazione in più. Antigiolittiani erano i liberisti e gli elitisti. Antigiolittiane erano le note di Einaudi sull’ “Economist” a commento dei governi di Giolitti. Antigiolittiani erano gli articoli della “Rivoluzione liberale”, dove Gobetti arrivava a ravvisare nel primo Mussolini un nuovo Giolitti, soltanto meno serio. Però Einaudi già nel 1922 corresse almeno in parte il tiro, facendo credito ai governi giolittiani del culto per la buona amministrazione; e il suo ultimo articolo per l’”Economist” fu scritto nel 1945 in memoria del fedelissimo giolittiano Marcello Soleri. E quanto a Gobetti, la graduale revisione del suo giudizio sui governi giolittiani è documentabile dall’inizio del 1924: anzi fu proprio Gobetti a tentare un accostamento azzardato, nonostante gli opposti temperamenti dei due personaggi, fra le idee di Giolitti e quelle di Salvemini. Resta certo come antitesi irreducibile la denuncia salveminiana del “Ministro della mala vita”: il contrasto fra il realismo di Giolitti, che intendeva il compito dello statista come quello del sarto chiamato a tagliare la giacca per un gobbo, e il moralismo di Salvemini, che faceva appello alle “minoranze coscienti che si costituiscono rappresentanti delle moltitudini mute”. La denuncia di Salvemini non faceva sconti al clientelismo filogovernativo del Mezzogiorno, ridotto a “Dronero del Sud”; salvo il fatto che Giolitti contribuì ad avviare il riscatto delle moltitudini mute con l’istituzione del suffragio universale maschile, grazie al quale lo stesso Salvemini fu eletto al Parlamento nel 1919. Poi venne per tutti la dura lezione della storia, e nel 1944 Salvemini, pur senza ritrattare la propria critica del giolittismo, ammise che nell’asprezza di quella critica, lo spirito del crociato aveva fatto premio in lui sul metodo dello storico. Quando lo storico esce dalla meditazione degli archivi per vestire l’armatura del crociato, è in obbligo di dirlo; Salvemini lo disse, seppure trent’anni dopo. Ad alimentare l’insofferenza verso Giolitti concorreva anche lo stile prosaico del personaggio, la sua invincibile allergia alle declamazioni oratorie, quel parlare pragmatico e laconico che gli era rimproverato dall’arcieloquente Vittorio Emanuele Orlando. Eppure un elitista come Filippo Burzio arrivò a identificare nell’antieroico Giolitti l’incarnazione del demiurgo, capace di sfidare l’impopolarità 19 in momenti di nazionalismo antieuropeo, di immunizzare la politica contro la “nausea degli ideali”, e persino di compiacersi del grigiore intellettuale che gli era addebitato. Non occorre infine ricordare come il più alto elogio del “buonsenso” (categoria fondamentale del pensiero giolittiano) fu scritto dall’idealista Croce, in quella Storia d’Italia dal 1871 al 1915 che al fascismo ormai consacrato opponeva la seria devozione alla Patria e il sentimento vero dello Stato della calunniata Italietta. Disgraziatamente il buonsenso è virtù di governo in tempi di normalità della vita pubblica, ma mostra i suoi limiti nelle ore fatali in cui l’etica assennata della responsabilità deve cedere il campo all’etica intransigente della convinzione. Le incomprensioni, le illusioni e i cedimenti della classe di governo liberale di fronte alla prima insorgenza del fascismo sono una pagina ingloriosa nella storia dei liberali italiani, e neppure il vecchio Giolitti, che in età meno avanzata aveva saputo reagire senza incertezze all’involuzione repressiva di fine Ottocento, seppe esserne immune. Nelle elezioni del 1921 a sistema proporzionale, in 22 circoscrizioni su 40 le liste liberaldemocratiche furono sostituite dai “blocchi nazionali” che portarono alla Camera 35 deputati fascisti, i quali peraltro votarono subito la sfiducia al governo di Giolitti. Nell’ultimo capitolo delle Memorie che si concludono con la caduta di quel governo, Giolitti tentò di giustificare il suo errore con il debole argomento che “tutte le forze del paese devono essere rappresentate nel parlamento e trovarvi il loro sfogo” ma l’errore costò caro alla causa liberale. Giolitti tentò di ripararvi nel 1924, contrapponendo al listone governativo di Mussolini la lista liberale che ebbe qualche successo almeno in Piemonte; ma aggiunse per spiegazione che la lista si riteneva non contraria bensì parallela al listone governativo, ed era stata formata allo scopo di contendere a socialisti e popolari parte dei seggi di minoranza. Lo svolgimento della campagna elettorale si incaricò di sgombrare ogni illusione talché dopo le elezioni a Giolitti restò soltanto di augurarsi che la nuova Camera riuscisse a fare dimenticare la sua origine. La stella di Giolitti era tramontata e i suoi ultimi richiami parlamentari allo Statuto caddero nel silenzio del Re, che nel 1928 ebbe la pavidità di non comparire al funerale del servitore della Corona, di cui pure secondo il cerimoniale dell’Annunziata si professava in calce alla corrispondenza “affezionatissimo cugino”. Ciò che rimane del liberalismo giolittiano è appunto ciò che fu interrotto e impedito dal fascismo: il processo verso la formazione in Italia di una democrazia liberale inclusiva. Non a caso il liberalismo di Giolitti radicava il proprio consenso nelle valli piemontesi che avevano custodito per secoli la fierezza della loro indole democratica; nella piccola borghesia dei contadini proprietari e poveri, laboriosi ed egualitari. 20 L’attitudine di Giolitti a farsi interprete della mentalità e degli interessi di quel ceto naturaliter liberaldemocratico, si può misurare alla prova dei programmi dei suoi cinque governi formati nell’arco di un trentennio. Qualche esempio può bastare. 1892: riduzione delle spese militari, fino ad allora considerate intoccabili. 1903: campagna contro l’analfabetismo. 1906: riduzione delle imposte di consumo (le imposte progressive alla rovescia) e legislazione sociale del lavoro (riposo settimanale, limiti al lavoro notturno, previdenza). 1912: suffragio universale maschile, destinazione alla previdenza sociale dei profitti assicurativi. 1920: avocazione allo Stato dei profitti di guerra, tassazione progressiva dei capitali. Una ricognizione più larga dell’opera parlamentare di Giolitti mostra come la sua azione politica, muovendo dalle esperienze iniziali in materia fiscale, si sia progressivamente estesa alla politica finanziaria a quella sociale, dalla politica sociale a quella interna, dalla politica interna a quella internazionale. Muovendo dall’esigenza di correggere l’iniquità del prelievo fiscale sui consumi essenziali il liberalismo di Giolitti sviluppa l’attenzione verso il malessere sociale come origine di conflitto e quindi perviene alla formula della neutralità dello Stato di fronte ai conflitti fra capitale e lavoro; dalla promozione sociale dei ceti popolari approda all’allargamento del suffragio, in funzione della piena rappresentatività del parlamento, che rimane nella visione giolittiana la sola voce legittima del paese ed insieme il sinonimo dell’autorità dello Stato; dalla concezione democratica della politica (contrapposta da Giolitti alla concezione imperialistica) matura il ripudio del bellicismo e la rivendicazione al parlamento delle decisioni in materia di pace e di guerra. Ma qui siamo ormai al Giolitti ottuagenario e al memorabile discorso del 12 ottobre 1919 agli elettori di Dronero: un discorso intessuto ancora una volta di dati, cifre, calcoli, rendiconti, e progetti di scelte pubbliche per risanare la finanza e l’economia; e che tuttavia si impenna alla fine a toni di inconsueta solennità. Fermezza e duttilità erano secondo Giolitti i due connotati complementari del riformismo. Nei confronti dei partiti di massa e delle organizzazioni del lavoro che iniziavano ad accamparsi nella vita pubblica, il riformismo giolittiano poteva far conto sui contrappesi ed equilibri sufficienti ad una strategia, appunto, ferma e duttile ad un tempo: la prevalenza moderata nel Senato regio, l’establishment dell’alta amministrazione, il controllo prefettizio utilizzato alla bisogna con durezza spregiudicata. Molti anni dopo, nel rievocare lo statista cui era legato per tradizione famigliare, Giovanni Malagodi quasi si dispiaceva per il fatto che nell’Italia degli anni sessanta mancassero quegli equilibri e contrappesi che avrebbero facilitato l’incontro fra liberali e socialisti, raggiunto poi nel 1979. L’occasione di questo volume del centro Pannunzio viene a proposito per ricordare come Malagodi, in contrasto con l’immagine prevalente che è 21 rimasta di lui per effetto della sua lunga opposizione al centrosinistra, idealmente fosse un liberale giolittiano. Suo padre, il senatore Olindo Malagodi, nel 1921 aveva indotto Giolitti a scrivere le memorie della sua vita, e il diciottenne Giovanni ebbe l’incarico di correggerne le bozze. Conservo un autografo in cui Malagodi ne rivendicava il ricordo. E non aveva dubbi di riconoscersi nella sua filiazione giolittiana, evocando lo statista dell’Italia liberale, secondo soltanto a Cavour, che aveva posto il pragmatismo, e all’occorrenza la spregiudicatezza, al servizio della modernizzazione sociale e civile del paese: opponendo all’irrazionalismo che infine lo travolse, il disegno concreto di promuovere le plebi alla cittadinanza, forte soltanto – scriveva Malagodi – della “fiducia, ahimè eccessiva, nell’efficacia del buon senso”.
Potrebbero interessarti
Articoli recenti
Categorie
Archivio
- Aprile 2025
- Marzo 2025
- Febbraio 2025
- Gennaio 2025
- Dicembre 2024
- Novembre 2024
- Ottobre 2024
- Settembre 2024
- Agosto 2024
- Luglio 2024
- Giugno 2024
- Maggio 2024
- Aprile 2024
- Marzo 2024
- Febbraio 2024
- Gennaio 2024
- Dicembre 2023
- Novembre 2023
- Ottobre 2023
- Settembre 2023
- Agosto 2023
- Luglio 2023
- Giugno 2023
- Maggio 2023
- Aprile 2023
- Marzo 2023
- Febbraio 2023
- Gennaio 2023
- Dicembre 2022
- Novembre 2022
- Ottobre 2022
- Settembre 2022
- Agosto 2022
- Luglio 2022
- Giugno 2022
- Maggio 2022
- Aprile 2022
- Marzo 2022
- Febbraio 2022
- Gennaio 2022
- Dicembre 2021
- Novembre 2021
- Ottobre 2021
- Settembre 2021
- Agosto 2021
- Luglio 2021
- Giugno 2021
- Maggio 2021
- Aprile 2021
- Marzo 2021
- Febbraio 2021
- Gennaio 2021
- Dicembre 2020
- Novembre 2020
- Ottobre 2020
- Settembre 2020
- Agosto 2020
- Luglio 2020
- Giugno 2020
- Maggio 2020
- Aprile 2020
- Marzo 2020
- Febbraio 2020
- Gennaio 2020
Contatti
Centro Pannunzio
Associazione culturale libera fondata a Torino nel 1968
Via Maria Vittoria, 35 H
10123 Torino (TO)
Tel 011 8123023
redazione@pannunziomagazine.it
www.centropannunzio.it