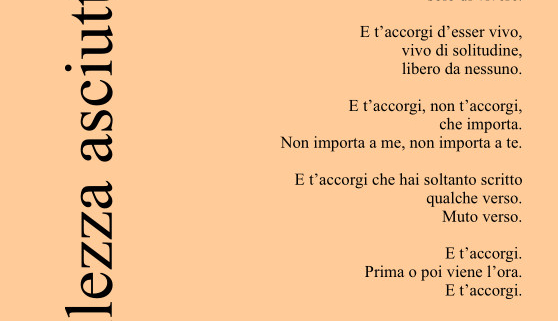La crisi dell’interiorità e la ricerca dell’identità personale e professionale in Una bellezza asciutta, di Michele Sabatini, Bertoni Editore, Perugia 2025.
Un libro di poesie decisamente fuori dal comune. Una bellezza asciutta di Michele Sabatini va oltre quel che abitualmente leggiamo come raccolta di testi poetici uniti da un filo sottile e spesso invisibile. Qui c’è anche un impianto narrativo, una storia, che è la narrazione per frammenti della sofferta ricerca di una possibile identità personale.
Ne parliamo perché il tema ha una sua centralità nel mondo d’oggi e ci pare che Sabatini, che è anche promotore e organizzatore di eventi culturali, abbia perfettamente capito che la ricerca, affannosa e problematica, della propria identità personale è argomento adatto alla poesia.
Lo è per la ragione esattamente contraria a quello che a prima vista potrebbe sembrare.
Si ritiene ancora oggi che l’io lirico costruisca l’io individuale che, personalizzandosi, si spende nel complesso mondo delle relazioni sociali. Purtroppo non è così. Era così nell’Ottocento romantico da cui il Novecento ha preso le distanze, scoprendo le ipocrisie dei bei sentimenti, dei presunti slanci ideali, delle belle parole. È la lezione di Eliot, di Pessoa, di Montale. L’io lirico, infatti, si frammenta e quasi si autodistrugge analizzando pensieri, sentimenti, convinzioni e si fa potenzialmente anarchico e disperato. Scopre la disobbedienza, il vuoto.
Così è anche in Sabatini, che sembra raccogliere tutta questa materia sostanzialmente impoetica, plasmandola per una pura necessità di sopravvivenza. Ed è in questo la forza della poesia.
Pensiamo all’ incipit di “Tarda mattinata” che riportiamo qui di seguito:
“Trovare forza dentro sé, / appeso ad una preghiera, / conquistando la pace / da ricordi e premonizioni. // Ritrovarsi la mente sgombra, / l’udito azzerato, / la vista miope del proprio naso / focalizzando meglio il da farsi”.
È un “risveglio” che non ha nulla di incoraggiante. Ma in questa realistica raffigurazione psicologica dell’esser desto, c’è più verità che non in una stanca celebrazione di valori che più sono tradizionali e meno funzionano.
Il valore deve valere, se non funziona va impietosamente buttato nella spazzatura, a costo di far piangere nonna. La poesia lo ha capito forse per prima, a partire dai “poeti maledetti”.
Nel tempo il giocare sofferto con la propria interiorità, si è fatto anche divertito, dando nuova vita e respiro al poeta. Si capisce allora che quello di una “bellezza asciutta” è in fondo un ideale estetico che scaturisce solo dalla poesia per ciò che la poesia dice e tace.
E siamo al punto cruciale. Che la poesia non si legga quasi più, quasi sconfitta in una competizione commerciale con la canzone è un fatto dei nostri giorni. Le canzoni si fanno comprare, perfino rubare, i libri di poesie si pubblicano e spariscono dalla circolazione. Non si trovano più neanche sulle bancarelle. Eppure il poeta, che non ha simpatia per la vetrina di Sanremo, ascolta, ama, fa suo quel che della canzone va apprezzato. Gli appartiene il grido “tutto il resto è noia!”. Sa che c’è un’eco sostanzialmente, irresistibilmente poetica, in quel piccolo, delizioso capolavoro di Franco Battiato, Giusto Pio e Carla Bissi che è “Per Elisa”, felicemente interpretato da Alice. È dai tempi di Elvis Presley che i giovani cantano e cantando dicono sciocchezze e banalità, ma anche a volte verità innegabili. E dalle canzoni che “non sono solo canzonette” la poesia è più pronta di quanto non si creda a trarre qualche ispirazione.
Vale qui la pena riportare per esteso “Viaggio”, una poesia di Sabatini particolarmente indicativa a questo proposito:
“Per un pomeriggio, / vorrei iniziare un viaggio: / qualcosa più di un sogno. // Un volto, un’immagine / da guardare, riconoscere: / come se il mio viso fosse di un altro.// Un cappello, un paio d’occhiali, una valigetta, / sfuggendo tra la gente, / a piccoli passi.// Fermarmi sul marciapiede, / sedermi sulla panchina, / guardarmi intorno. // Null’altro che guardare / e non esser visto: / come se non esistessi. // Piccolo rifugio d’intimità, / libero da occhi altrui, / inizierei a conoscere il mondo. // Senza giudicare, / esente da problemi e doveri, / novello barbone, farei i fatti miei”.
Se qui il lessico fa pensare a Gianni Rodari, il tono, che non è polemico, è però dichiaratamente protestatario come si esplicita nel finale, dove il giudicare perde la gravità del saggio sentenziare per indicare l’attitudine volgare allo spettegolare che – come sanno tutti gli adolescenti che vanno a scuola – ci spersonalizza, impedendoci di crescere “facendoci i fatti nostri”. Espressione quest’ultima che non indica qui una tendenza all’egoismo ma un voltare le spalle alla pretesa di giudicare gli altri.
Di qui delle immagini insolite, quasi folgorazioni spontanee, come in “Insonnia”: “Rispondo come un ateo: / non voglio carità o dolore. / Quello che ho non m’appartiene”.
“Quello che ho non m’appartiene” sa di canzonettistico e sarebbe bello sentirlo cantare. È una verità della vita d’oggi che riguarda particolarmente il mondo dei giovani alla ricerca a volte dolorosa e penosa di una propria identità personale. La moda impone di far proprie tante cose di cui non abbiamo alcuna necessità. Abbiamo tanto e ci manca sempre qualcosa che non troviamo.
Quanto al poeta, si autodefinisce con queste parole, tra il dolce e il sardonico:
“Un teatro, piccolo o immenso che sia, / un copione da protagonista. / Ed io seduto in platea, / spettatore ad applaudire un altro”.
A parte l’autoironia, Michele Sabatini recupera, con Una bellezza asciutta quanto di meglio resta della tradizione dell’ermetismo, che nei suoi epigoni, s’era ridotto a una forma di impressionismo dai toni convenzionalmente lirici. Sabatini costruisce un tracciato diverso, ricco di accenti nuovi e di un lessico disinvoltamente e decisamente inclusivo del quotidiano, come presagito da Montale.