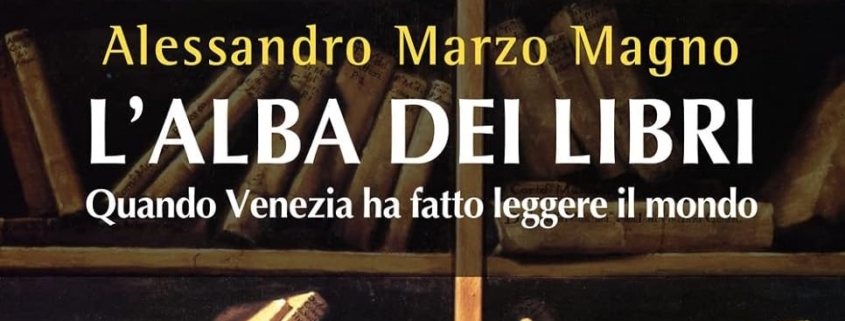Dove venne pubblicato il primo Corano in arabo? E i primi libri in armeno, greco o in cirillico bosniaco? Dove sono stati venduti il primo tascabile e i primi bestseller? A Venezia, tra i canali della Serenissima. A raccontare questa straordinaria storia ci ha pensato tempo fa Alessandro Marzo Magno in un volume intitolato L’alba dei libri. Quando Venezia ha fatto leggere il mondo. Nella grande metropoli europea sulla laguna – perché all’epoca solo Parigi, Venezia e Napoli superavano i 150 mila abitanti – videro la luce anche il primo libro di musica stampato con caratteri mobili, il primo trattato di architettura illustrato, il primo libro di giochi con ipertesto a icone, il primo libro pornografico, i primi trattati di cucina, medicina, arte militare, cosmetica e i trattati geografici che fecero conoscere le scoperte di spagnoli e portoghesi al di là dell’Atlantico. A Venezia i libri erano davvero importanti e occupavano un posto di tutto rispetto. La Serenissima, a quel tempo, ospitava le più grandi tipografie del mondo, in grado di stampare in qualsiasi lingua la metà dei libri pubblicati nell’intera Europa. Committenti stranieri ordinavano volumi in inglese, tedesco, cèco, serbo. Appena pubblicati, venivano diffusi ai quattro angoli del mondo. Il protagonista di questa rivoluzione libraria, il pedagogo romano Aldo Manuzio, arrivò ormai quarantenne a Venezia. Tra le calli e i sestieri trovò l’ambiente giusto che gli consentì di attuare il suo sogno culturale. Fu lì che inventò il mestiere dell’editore, contribuendo a rivoluzionare il mondo della cultura e dell’arte del suo tempo. In breve tempo, Manunzio divenne “il principe degli editori”, inventando il libro in formato tascabile e un nuovo carattere, il corsivo, che tutto il mondo chiama “italic”, curando la raffinatezza, senza indulgere in troppi fronzoli, dell’impaginazione e soprattutto inventandosi il pubblico dei libri. Nel suo progetto di acculturazione generale i fruitori non erano più solo gli eruditi delle università e dei monasteri ma tutte quelle persone, ovviamente benestanti, che amavano leggere per diletto e per arricchimento personale, senza mire accademiche. Ecco perché le edizioni di Manuzio erano filologicamente impeccabili, ma prive di commentari e di annotazioni. Prima che il geniale pedagogo inventasse la figura dell’editore moderno, gli stampatori erano solo artigiani attenti al guadagno immediato, poco attenti ai testi che riempivano di errori. Manuzio si lanciò in progetti a lungo termine e li curò con la dovuta attenzione, pubblicando tutti i maggiori classici in greco e in latino, scegliendo la lingua italiana per i libri a maggiore diffusione. Importò dal greco al volgare la punteggiatura che utilizziamo ancora oggi: la virgola uncinata, il punto e virgola, apostrofi e accenti. Dalla sua tipografia uscirono il capolavoro assoluto della storia dell’editoria, l’Hypnerotomachia Poliphili (letteralmente Combattimento amoroso di Polifilo in sogno), attribuito a Francesco Colonna (1499), ma anche il bestseller del Cinquecento, il Cortegiano di Baldassar Castiglione, una sorta di libro-cult della nobiltà europea. Alessandro Marzo Magno, veneziano di nascita, scrittore e giornalista (per dieci anni responsabile degli esteri del settimanale Diario, collaborando poi con Focus, Il Sole 24 ore e il Gazzettino), nel suo libro accompagna il lettore alla scoperta della straordinaria avventura imprenditoriale e culturale della prima industria moderna. La Serenissima restò la capitale dei libri finché la Chiesa, che considerava la libertà di stampa un pericolo, non impose la censura dell’inquisizione. La libertà di stampa, a quel punto, cercò nuovi rifugi nell’Europa del Nord e il nostro paese, una volta di più, perse un’altra delle tante buone occasioni.
Articoli recenti
Categorie
Archivio
- Marzo 2025
- Febbraio 2025
- Gennaio 2025
- Dicembre 2024
- Novembre 2024
- Ottobre 2024
- Settembre 2024
- Agosto 2024
- Luglio 2024
- Giugno 2024
- Maggio 2024
- Aprile 2024
- Marzo 2024
- Febbraio 2024
- Gennaio 2024
- Dicembre 2023
- Novembre 2023
- Ottobre 2023
- Settembre 2023
- Agosto 2023
- Luglio 2023
- Giugno 2023
- Maggio 2023
- Aprile 2023
- Marzo 2023
- Febbraio 2023
- Gennaio 2023
- Dicembre 2022
- Novembre 2022
- Ottobre 2022
- Settembre 2022
- Agosto 2022
- Luglio 2022
- Giugno 2022
- Maggio 2022
- Aprile 2022
- Marzo 2022
- Febbraio 2022
- Gennaio 2022
- Dicembre 2021
- Novembre 2021
- Ottobre 2021
- Settembre 2021
- Agosto 2021
- Luglio 2021
- Giugno 2021
- Maggio 2021
- Aprile 2021
- Marzo 2021
- Febbraio 2021
- Gennaio 2021
- Dicembre 2020
- Novembre 2020
- Ottobre 2020
- Settembre 2020
- Agosto 2020
- Luglio 2020
- Giugno 2020
- Maggio 2020
- Aprile 2020
- Marzo 2020
- Febbraio 2020
- Gennaio 2020
Contatti
Centro Pannunzio
Associazione culturale libera fondata a Torino nel 1968
Via Maria Vittoria, 35 H
10123 Torino (TO)
Tel 011 8123023
redazione@pannunziomagazine.it
www.centropannunzio.it