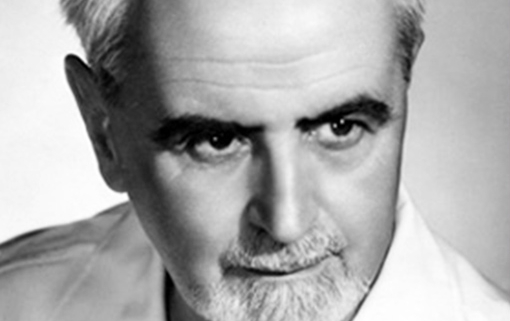Ho avuto sempre un culto parzialmente acritico verso Ernesto Rossi. Per questo culto venni persino nel secolo scorso insignito di un Premio Rossi che è ancora appeso da qualche parte nel mio studio. Ho anche commemorato Rossi nell’Aula Magna dell’Università di Torino per qualche anniversario. Debbo dire che non avevo mai approfondito in modo adeguato il tema, fermandomi al rispetto ammirato (che resta inalterato) verso chi patì carcere e confino a causa di un antifascismo coraggioso che ebbe remote radici in un fascismo iniziale, che portò Rossi a scrivere sul “Popolo d’Italia“ di Mussolini. Oggi dopo le polemiche stolte e le visite celebrative mancate a Ventotene, sono indotto a scrivere qualcosa che non avrei pensato di dover scrivere. Ma forse anche gli isterismi di Fornaro sono utili e inducono a riflettere anche se in modo opposto ai suoi desideri in verità non documentati. Una biografia di Giuseppe Fiori aveva già contribuito a parlare senza limiti celebrativi di questo erede della nobile famiglia piemontese dei Rossi della Manta, figlio di un colonnello che si separò per gelosia dalla moglie in modo drammatico nel 1913, creando un grave trauma al giovane Ernesto, che sentì di essere rimasto senza famiglia. Il legame quasi filiale con Gaetano Salvemini va letto anche in questo modo e non solo perché fu Salvemini a ricondurlo nella trincea antifascista dopo lo sbandamento di Rossi verso il fascismo. Partito volontario per la grande guerra, fu considerato per ragioni fisiche non idoneo alla trincea e tornò alla vita civile, deluso come molti altri reduci. Si laureò a Siena in Giuridprudenza con una tesi su Pareto , non proprio un padre della democrazia liberale , ma i suoi studi di economia furono disordinati e non sistematici e il rapporto con Luigi Einaudi e il suo liberismo fu più esibito che praticato, come l’odio verso Croce apparve una scelta più d’istinto che di riflessione. Rossi insegnò Economia per brevi periodi in Istituti tecnici statali tra cui quello di Bergamo dove incontrò la futura moglie Ada (con cui ebbe un tenerissimo rapporto e una solidale complicità politica durata l’intera vita) e venne arrestato.
Il lungo periodo di carcere duro non consentì, come a nessun altro carcerato, studi metodici, ma letture disordinate e discussioni politiche intellettualmente non diversificate. Le dure regole del carcere non consentivano di più. Rossi non era un ricco come Carlo Rosselli che poté persino fuggire dal confino a bordo di un motoscafo , Rossi non poté neppure espatriare all’estero e aprire la sua cultura ad ampi confronti come ebbero la possibilità di fare Saragat, Nenni e perfino Togliatti, schiavo di Stalin, ma nelle condizioni di aprirsi a vasti contatti per la sua posizione internazionale all’interno del mondo comunista. Uscito dal carcere, Rossi venne mandato al confino a Ventotene. Qui si ebbe l’incontro con Altiero Spinelli, allora rivoluzionario di mestiere, che non conseguì mai una laurea e possedeva una cultura liceale lacunosa. Come è stato autorevolmente scritto sull’ Enciclopedia Treccani, i residui di cultura leninista di Spinelli (che pure era stato cacciato dal PCI)e le impazienze giacobine di Rossi confluirono nella proposta di un partito rivoluzionario che imponesse la soluzione federalista ancor prima che essa fosse maturata nella coscienza dei popoli europei. Così nacque il Manifesto di Ventotene, espressione di un europeismo autoritario e velleitario, quasi totalmente privo della conoscenza del quadro storico, politico e militare del 1941 ed anni successivi. Privi di carta, essi scrissero il futuro manifesto su cartine da sigarette. Esso nacque nelle condizioni più eroiche, ma anche più infelici ed inadatte ad una riflessione matura.
Nulla a che fare con la dichiarazione della Rivoluzione americana del 1776 o con quella francese del 1789 che maturarono in altri contesti e con l’apporto di altre intelligenze. Si creò il mito del Manifesto che divenne un feticcio, quasi un totem intoccabile che pochi lessero e quasi tutti venerarono. Anche Spadolini andò a celebrare una laica messa cantata a Ventotene che sarebbe interessante a riuscire a recuperare. Io quando lessi il manifesto avevo appena finito l’università e silenziosamente mi dimisi dal MFE che faceva del Manifesto il suo principale riferimento. Capii che esso confliggeva con il mio liberalismo democratico. Rimasi europeista alla maniera di Einaudi e di De Gasperi, ma commisi l’errore di non aprire una qualche riflessione critica almeno nel Centro “Pannunzio”. Rossi successivamente aveva un po’ stemperato il suo spirito guerriero, esaltato da Pajetta quando egli morì nel 1967, e scrisse sul “Mondo” di Pannunzio dal 1949 al 1963. Le sue polemiche e le sue inchieste furono la fortuna del giornale, ma Rossi non scrisse mai un libro di economia degno di attenzione. Ebbe un piccolo premio secondario dall’Accademia dei Lincei, ma non ottenne mai la docenza universitaria a cui pure aspirava. Il figlio di Einaudi Mario che insegnò negli USA e che mi onorò della sua amicizia, mi parlò di Rossi come di un polemista coraggioso, ma “quasi digiuno di scienza economica“. Il presidente Einaudi gli voleva bene e lo ricevette al Quirinale ma aggiunse che non era uno studioso, ma un polemista spesso astioso. Il suo anticlericalismo viscerale fu un esempio del suo stile, incompatibile ad un intellettuale liberale che sa misurare con “circospezione“ le parole, come avrebbe detto Bobbio. Alla fine si distaccò dal “Mondo per la squallida vicenda dell’antisemita Piccardi che Rossi difese in modo impudico, cercando di tramare contro Pannunzio una accusa di filofascismo falsa e sleale, perché imbastita quando lavorava alla redazione del “Mondo”. Pannella ebbe simpatia per Rossi, ma in un colloquio molto confidenziale con me lo ritenne un ottimo combattente politico, ma non uno studioso attendibile.
Per fare un manifesto ideale per l’Europa ci volevano altri uomini. Spinelli e Rossi non bastava no e i tempi non erano maturi per delineare il futuro dell’Europa. La Costituzione europea bocciata da Francia e Olanda che fu definitivamente accantonata nel 2007, avrebbe avuto lo spessore per essere il Manifesto dell’Europa unita. Ma così non vollero residui giacobini ancora presenti in Europa.Tutti questi “europeisti“ non studiarono Federico Chabod e non lessero “Storia dell’idea d’Europa“ che raccoglie le lezioni tenute nel ’43/’44 a Milano. Quasi sicuramente Spinelli e Rossi non sapevano neppure dell’esistenza del più grande storico dell’Europa così come Chabod non fu successivamente un sostenitore del Manifesto.